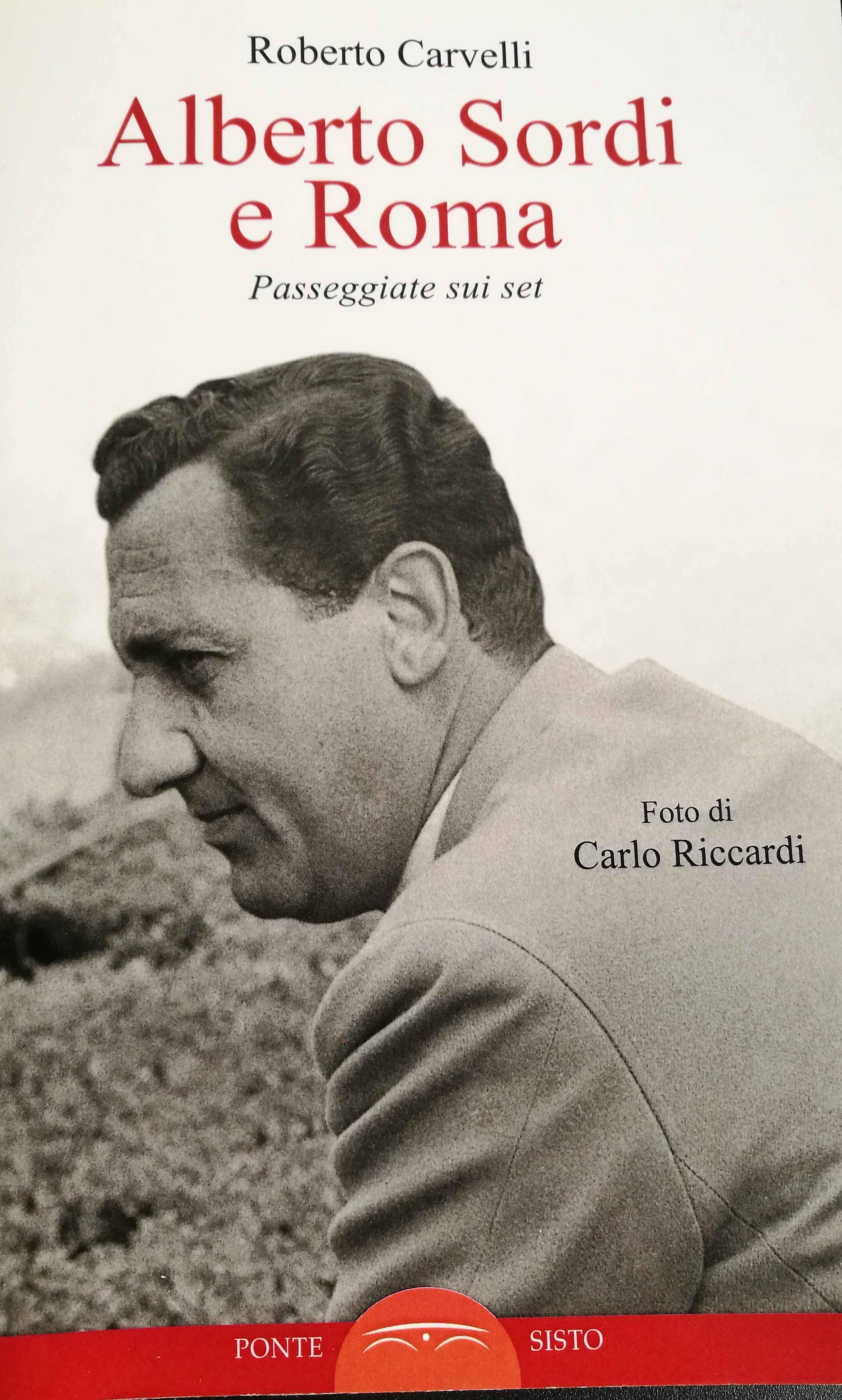Giuseppe Gioachino Belli
Ricordiamo – non potrà essere né la prima né l’ultima volta vista la statura dell’autore – Giuseppe Gioachino Belli. Ma questa volta compiutamente: utilizzando e per ciò ringraziando Marcello Teodonio e Castelvecchi, rispettivamente autore ed editore di questa preziosa “Vita di Belli”. Un saggio imprescindibile per conoscere questo autore a cui tanto dobbiamo della storia del nostro dialetto, della nostra romanità. Anche la fierezza di poterli vantare riferiti a lui. Uniamo l’estremo interesse, fuori dai versi, anche del carattere dell’uomo e il gioco è fatto.
E il fatto è che l’avventurosa vicenda non è secondaria per apprezzarne la grandezza poetica (e la voluminosità, si veda lo “score”: 32.000 versi in romanesco, più di 45.000 in italiano – non male). Ci premuriamo d’iniziare dall’inizio omettendo solo per ragioni di brevità le due introduzioni. Ma vi regaliamo questo bel modo di dire del Belli stesso con cui si apre la seconda: «Scastagnamo ar parlà ma aramo dritto». E come Belli e Teodonio iniziamo dalla nascita e dal capitolo che apre la vita di GGB.
Dal Primo Capitolo («IO NACQUI A ROMA DI PARENTI ROMANI» 1791-1798) di “Vita di belli”.
Il 7 settembre 1859 Giuseppe Gioachino Belli scrive alla nuora Cristina:
Cristina mia cara
Nacque nel 1791 Giuseppe Gioachino Belli, il giorno settimo di settembre,
alle ore 18 (come in quel tempo si diceva) ossia, come dicesi adesso, ad
un’ora pomeridiana. Da tuttociò si conchiude che il Signor Giuseppe
Gioachino Belli (seppure è ancora vivo, che io nol so bene) in questo preciso
momento ha compiuto l’anno sessantesimo-ottavo della età sua, e già
cammina sulla strada del sessagesimonono. Intanto il Tevere corre e correrà
sempre come il Signor Giuseppe Gioachino non fosse mai nato.
Il 7 settembre di tanti anni prima, dunque, in una Roma al tempo stesso diversissima
e sempre uguale a se stessa, come fa pensare quell’accenno al
corso del Tevere comunque indifferente ai destini umani, era nato Giuseppe
Gioachino Belli.
E se la data di stesura della lettera precede di soli due anni la proclamazione
dell’Unità d’Italia, l’anno della nascita di Belli vedeva la furibonda reazione
antigiacobina e antirivoluzionaria che, proprio dalla Città santa, s’andava
diffondendo all’intera Europa in nome del recupero e della rifondazione
dei valori messi in crisi dal «fanatismo della rivoluzione di Francia» che
aveva «quasi distrutte» la monarchia e la religione.
Il 10 marzo 1791 un breve papale, che condannava in maniera assoluta e
violentissima le idee di Francia, aveva segnato l’inizio di una fiorente pubblicistica
polemica dai toni allucinati e parossistici che dava della Rivoluzione
Francese l’immagine di una diabolica sovversione voluta da uomini malvagi
ed empi e in cui la Francia prerivoluzionaria era presentata come il Regno
più prospero e felice della Terra perché retto dal Re «il più amabile pe’ suoi
costumi, il più rispettabile per la politica del suo Gabinetto, il più commendevole
pel suo attaccamento alla Cattolica Religione».
Tutti i nemici della religione
e della monarchia, filosofi, massoni, giansenisti, s’erano coalizzati in
un complotto uniti dalle empie opinioni che si son fatte rivivere dalle tombe de’ più antichi Ateisti,
dove rimanevano sepolte, queste tesi figlie della cattedra di pestilenza, queste
dottrine le più depravate, ed oscenità le più immonde, queste lepidezze
infernali, con cui si pone in derisione quanto v’ha di più sacro, e d’augusto
nella terra, e nel Cielo, queste infami bestemmie contro il più saggio ordine
dato alla natura, ed al mondo dall’eterno Dispositore.
L’accusa è ideologicamente avveduta: i fiumi di sangue, le rovine, le devastazioni,
perfino il cannibalismo a cui sono dediti i capi della rivoluzione,
sono anzitutto l’effetto di una empietà culturale, di un errore originario, la
pretesa cioè di sostituire l’ordine naturale delle cose. E siccome «le massime
francesi, e l’empietà dei loro libri si sono dilatate a misura che è propagato
l’uso della loro lingua», si arrivò a proporre che si formassero «società
di Giovani, in tutti i paesi, e specialmente d’Italia, i cui membri facessero
almen proposito di non mai imparare la lingua francese, durante la lor
gioventù, per essere nella fortunata impossibilità d’intendere i loro libri»:
insomma, si proponeva un vero e proprio bando del francese «da tutte le
Corti, da tutte le Università, da tutti i Collegi, da tutti i Seminari, da tutte
le case».
Anche il giornale «ufficiale» di Roma, il minuscolo «Cracas», come fu
sempre chiamato nella sua lunghissima vita, seguiva le vicende d’oltralpe in
tutte e due le sue edizioni settimanali: il «Diario Estero», dedicato appunto
alle vicende internazionali, e il «Diario Ordinario», che invece si occupava
in prevalenza delle vicende interne e in particolare di quelle romane (cronache
di funzioni sacre, matrimoni e malattie di nobili, pranzi generosamente
offerti da principi e aristocratici con la diligente segnalazione del numero
dei coperti, ecc.). Tra l’ottobre e il novembre 1791 il «Diario Ordinario»5 dà
eccezionale risalto alla «Lettera delle LL.AA. Reali il Signor Conte di Provenza
e il Signor Conte D’Artois al Re loro Fratello» Luigi XVI: le «criminose
intraprese» dell’Assemblea hanno ormai svelato il loro vero obiettivo,
che è quello di distruggere il potere del Re; per questo tutti i sovrani d’Europa
sono pronti a intervenire per «sostenere la parte sana della Nazione
contra quella che delira», contro una truppa di faziosi, «una setta orgogliosa
che ha risoluto di distruggere ogni Religione, e conseguentemente di scatenare
tutti li delitti».
Ma accanto a queste drammatiche informazioni, il giornale riporta notizie
di cronaca cittadina, quasi a fornire un quadro rassicurante della continuità e
della normalità della situazione. Nel «Diario Ordinario» del 10 settembre
1791 (quando cioè Belli era nato da tre giorni), si legge che «essendo sopraggiunto
alla Sig. D. Isabella Petroni Contessa Bolognetti, nella scorsa settimana
un mal di reuma, e febbre, i Medici gli fecero fare alcune emissioni di
sangue, ed applicare li Vescicanti, con l’ajuto de’ quali, e di altri rimedi, fin da
Lunedi incominciò a risentire del miglioramento, ed in seguito è andata sempre
più sollevandosi nella sua salute, con piacere del suo nobile Parentado».
Sullo stesso giornale si legge poi che per l’8 settembre, «ricorrendo la
Festa della Natività di Maria Vergine», s’erano celebrate funzioni sacre «con
ricco apparato» nella chiesa di Santa Maria del Popolo, e «con vago apparato»
nella chiesa «di S. Maria dell’Anima della Nazione Teutonica, ove terminata
la Messa, da’ quei Signori Deputati fu distribuito il Sussidio Dotale ad
un buon numero di Zitelle figlie di Nazionali». La stessa festa era stata celebrata
anche a Santa Maria in Vallicella «detta la Chiesa Nuova» con «vago
apparato, sagre decorazioni, e solenne Messa», nella basilica di Santa Maria
Maggiore, a Santa Maria in Cosmedin «detta la Bocca della Verità», nella
chiesa di Santa Maria di Loreto «con ricco apparato, solenne Messa, e vespri
accompagnati da scelta musica», nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva,
nella chiesa di Santa Maria d’Aracoeli, eccetera, «ed in tutte è stato numeroso
il concorso del Popolo per l’acquisto delle plenarie indulgenze».
Il 10 settembre, nelle prime ore del pomeriggio, «la Reale Principessa di
Francia Maria Adelaide si partì a fare una camminata fuori della Porta di S.
Giovanni»; il 12 novembre «l’Emo Sign. Card. Borromei sono alcuni giorni
che è obbligato a guardare il letto per il male di podagra, benché al presente
si trovi molto migliorato», mentre la sera di mercoledì 9 novembre «si restituirono
in Roma, provenienti da Pesaro, il Principe e la Principessa Doria
Pamphilj con i Signorini loro Figli, nel più perfetto stato di salute». Una settimana
dopo7 il lettore viene informato che «con le stampe di Perego Salvioni
è stata pubblicata un’operetta su la natura, uso ed effetti del Caffè», argomento
che «è nel nostro secolo sicuramente nuovo»: costa «soli baj. 15». Se
dunque i tempi erano certamente calamitosi, tuttavia anche allora il Tevere
continuava il suo corso, a novembre seguiva il Natale, e al Natale il Carnevale.
E Carnevale era la festa romana per eccellenza, il momento in cui la città
tutta viveva un breve, entusiasmante e disperato attimo di follia atteso tutto
l’anno, la festa dell’eccesso e della maschera, del disordine e della liberazione,
dell’infrazione e della «grascia», quell’abbondanza invocata per esorcizzare
la fame e il digiuno della successiva Quaresima.
Una tradizione ormai secolare ne aveva codificato i tempi, e la Chiesa, pur
condannando in linea di principio una festa indubbiamente pagana nelle
forme e nella motivazione profonda, l’aveva sempre tollerata, cercando di
controllarne gli eccessi e gli eventuali pericoli per l’ordine pubblico che potevano
derivarne e che in effetti poi si verificavano nella forma di omicidi, vendette,
furti, favoriti dal clima di generale licenza. Questa ambiguità costituiva
uno degli elementi più affascinanti del Carnevale romano e si traduceva in
una analoga ambiguità di comportamento delle istituzioni, come rivela ad
esempio il fatto che quello era diventato il momento in cui si eseguivano le
«giustizie» dei personaggi più noti, a partire dal famigerato caso del rogo di
Giordano Bruno.
Il Carnevale, dunque, nel corso del tempo, s’era trasformato in una festa
sfarzosa, durante la quale venivano sperperate enormi somme pubbliche e
private per rappresentazioni teatrali, balli, giostre, e soprattutto per la sfilata
delle maschere (e nessuno a Roma rinunciava a mascherarsi) che si svolgeva
lungo via del Corso, dove s’affacciavano i principali palazzi della città. Due
fila ininterrotte di carri e di maschere percorrevano parallelamente la via,
mentre una pioggia di fiori, di aranci, di carta colorata, di confetti e di «confettacci»
(e cioè confetti di gesso) cadeva su carrozze e persone. La sera di
martedì grasso si svolgeva la festa dei «moccoletti»: ogni maschera usciva per
il Corso con un lume colorato; qualcuno lo portava in mano, altri in cima a
pertiche, altri ancora sulla testa. Il gioco consisteva nel cercare di spegnere il
moccolo altrui e al tempo stesso mantenere acceso il proprio, e il tutto avveniva
fra schiamazzi, grida e scherzi vari.
Goethe, a Roma nel Carnevale di
quattro anni prima, aveva osservato che durante la festa ogni follia è lecita:
un gruppo di Pulcinella aveva eletto un grottesco e osceno monarca, una
donna aveva simulato il parto di una creatura mostruosa, e tutti gridavano
«sia ammazzato chi non porta moccolo»; insomma, «le scene più importanti
della nostra esistenza», il sesso, la nascita, la morte, erano rappresentate e
concentrate in un momento di totale liberazione che arrivava a quel grido
scandaloso (ma quanto liberatorio…) lanciato da un bambino durante la battaglia
dei moccoli: «Sia ammazzato il signor padre». Poi, all’Ave Maria, il rintocco
lugubre e minaccioso delle campane segnava la fine della festa, tutto
doveva cessare, sotto minaccia di gravi pene, per introdurre al clima austero
e castigato dell’espiazione e della catarsi della Quaresima.
Il Carnevale del 1792, nonostante le notizie provenienti dalla Francia, era
atteso con la solita grande trepidazione. S’erano così resi necessari «i soliti
Editti pubblicati per ordine e con l’oracolo della Santità di Nostro Signore»
(il Papa) che vengono riportati con grande evidenza nel numero del 18 febbraio
1792 del «Diario Ordinario»: anzitutto venivano proibiti i «confetti di
gesso con puzzolana, che da qualche tempo erano stati introdotti»; poi veniva
prescritto il regolamento per la corsa dei berberi e per lo «stabilimento
de’ Palchetti al Corso e alla Piazza del Popolo»; infine «un altro ben diffuso
Editto» indicava gli «ottimi Regolamenti da osservarsi per mantenere il buon’ordine,
e quiete nella Città negli otto giorni, e specialmente nella strada del
Corso».
In particolare veniva proibita, «come ne’ due anni scorsi», «l’illuminazione
de’ così detti moccoletti»: nessuna persona, «di qualunque sesso, età,
grado, e condizione, con maschera, o senza, per le strade tanto a piedi che in
carrozza, nelle finestre, ne’ Teatri, ed in qualunque altra maniera, o luogo
pubblico, o privato» poteva fare «illuminazione di sorta alcuna con candele,
moccoli, lanterne, lanternoni, fiaccole o con ogni altra sorta di materiale
combustibile», e tantomeno poteva poi «girar per la Città urlando, schiamazzando,
insultando, o facendo altra azzione relativa alla costumanza suddetta».
La pena prevista arrivava fino al carcere per cinque anni e si invitava
chiunque a denunciare gli eventuali colpevoli dietro compenso di «scudi
dieci da pagarsi sulli Beni de’ Trasgressori medesimi».
Quell’anno poi, il giorno delle Ceneri, il 22 febbraio, era anche l’anniversario
della «solenne coronazione del beneficentissimo nostro Principe ed
universal Pastore Sommo Pontefice Pio Sesto», e per celebrare l’avvenimento
«nella Cappella Sistina del Palazzo Vaticano fu tenuta la solita Cappella
Papale» alla presenza degli «Emi Cardinali in numero di 19, dei Conservatori»
e di «tutti gli altri che godono l’onore di assistere a tali funzioni», i
patriarchi, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati mitrati e i padri penitenzieri
della basilica vaticana, tutti vestiti «degl’abiti sagri secondo il loro Ordine».
Durante la cerimonia fu «dottamente pronunziata» la «solita orazione latina».
Alla fine, «terminata la Cappella, l’Emo Card. Braschi per la ricorrenza
della detta coronazione ricevé i complimenti, per mezzo de’ relativi Gentiluomini,
degli Emi Sigg. Cardinali, e di altra primaria Nobiltà».
La corte insomma continuava a celebrare i suoi trionfi e le sue cerimonie,
laiche e religiose, proprio mentre si rendevano esplicite le prime concrete
manifestazioni di disagio e perfino di ribellione nelle province pontificie (a
Fano, proprio nel settembre 1791, s’erano verificati gravi tumulti per il rincaro
della farina, culminati poi nel saccheggio dei magazzini e nella momentanea
occupazione della fortezza). La tensione era il risultato di uno squilibrio
interno di vecchia data, coerente a uno sviluppo che vedeva Roma, non
per nulla definita la Dominante, in posizione di privilegio rispetto al resto del
territorio: le province dovevano produrre ricchezza e beni di consumo per
tutto lo Stato, e soprattutto per la capitale affollata e senza risorse.
Tratto da “Vita di Belli” di Marcello Teodonio, Castelvecchi 2016. © Lit Edizioni Srl – Per gentile concessione dell’Editore