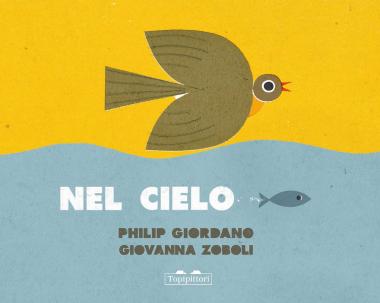Il Signor Cevdet
Il primo romanzo del premio Nobel turco Orhan Pamuk, “Il signor Cevdet e i suoi figli”, una lettura.
E’ il primo romanzo del premio Nobel turco Orhan Pamuk, “Il signor Cevdet e i suoi figli” (traduzione di Barbara La Rosa Salim, revisione di Şemsa Gezgin, Einaudi, 2011, pp. 683, € 24,00) e la nostra sensazione è che il monumento unitario formato dalle sue opere si sia arricchito delle sue fondamenta.
Il tema di Pamuk è, da sempre, la dialettica tra Oriente e Occidente nel suo Paese, una Turchia che ha una grande estensione anatolica, ma ha il suo centro a Istanbul, nell’elegante quartiere di Nişantaşı, dove sorge il palazzo Pamuk, in una stanza del quale c’è un tavolo su cui l’autore, con carta e penna, ha cominciato a creare il suo mondo letterario poco più che ventenne, dopo aver abbandonato il sogno di diventare pittore.
In “Istanbul” (2003) Pamuk avrebbe raccontato la sua infanzia e la sua giovinezza fino al 1975. Dal 1974 al 1978 si era chiuso nella sua stanza a scrivere “Il signor Cevdet e i suoi figli”, pubblicato poi nel 1982. Per paradosso, possiamo dire che il romanzo giovanile comincia dove finisce Istanbul. Epopea dell’Est e dell’Ovest vissuta in seno a tre generazioni di una famiglia borghese esemplata su quella dell’autore, “Il signor Cevdet e i suoi figli” si apre con il 1905, anno che prelude all’ascesa politica dei
Giovani Turchi e alla fine dell’Impero ottomano.
Prosegue nel periodo intorno al 1938, in cui si festeggia il quindicennale della Repubblica fondata nel 1923, muore Atatürk e si addensano le ombre del secondo conflitto mondiale, per poi concludersi nel 1970, poco prima del colpo di stato militare che ferisce sia le forze di sinistra, sia gli islamisti.
Le tre generazioni della famiglia di Cevdet, ricco commerciante musulmano (in un epoca in cui il commercio di Istanbul era in mano ad armeni, greci ed ebrei) abile negli affari ed estraneo alla politica, si succedono, nonostante la mole del romanzo, con grande velocità, come fotografate ciascuna a trent’anni di distanza.
Nel capitolo “La notte e la vita” (I, 12), ad esempio, il trentasettenne Cevdet si chiede se sarà felice con la sua futura sposa Nigân, timida figlia di un pascià fedele al sultano, ma grande bevitore ed economicamente quasi al collasso. Poche pagine dopo Cevdet è già nonno, un po’ svanito, e i figli Osman e Refik gli rubano la scena.
Al pacato Cevdet, che, per essersi aggiudicato in esclusiva la fornitura di lampade al Comune, si guadagnerà il cognome di Işıkçı (‘L’Elettricista’, in traduzione, ma sarebbe più chiaro ‘L’Illuminatore’), si oppone il fratello Nusret, impetuoso sostenitore dell’illuminismo (tutt’altra luce) e della rivoluzione francese; al solido Osman si contrappone Refik, perennemente insoddisfatto, cui si affiancano gli amici con i quali ha studiato ingegneria all’università: Ömer, che si sente un conquistatore come il balzacchiano Rastignac, e Muhittin, che invece è malinconico e brutto, ama
Baudelaire e vuole diventare un grande poeta entro i trent’anni, o altrimenti suicidarsi.
Ziya, il nipote di Cevdet, un Işıkçı anche lui, ma inviso alla famiglia, declinerà il suo ruolo di “portatore di luce” diventando ufficiale dell’esercito (risuona forse nel suo nome quello del teorico nazionalista Ziya Gökalp). Il romanzo, strutturato sulle opposizioni caratteriali dei molti personaggi, è un succedersi di dialoghi, anche interiori e non detti. Benché le pagine dedicate a Cevdet non siano molte, è giustamente suo il nome che compare nel titolo, perché i suoi dialoghi con il fratello e con il futuro suocero sono tra i più belli e significativi del testo.
Se Cevdet contiene in nuce la successiva produzione dell’autore, la sua prima parte è la radice del suo sviluppo futuro, quella cioè in cui ci si comincia a chiedere “chi sono e cosa devo fare della mia vita”. Questa domanda è un tema che musicalmente si sviluppa in infinite variazioni. La musicalità è sottolineata da ripetizioni ritmiche di parole e concetti (essere un Rastignac, suicidarsi, il conflitto per la provincia di Hatay), o da riapparizioni di personaggi anche a distanza di centinaia di pagine (caso limite: uno sconosciuto Cenap Sorar, citato in un banale articolo di cronaca a pag. 130, ricompare a pag. 613 come secondo marito di una delle protagoniste della storia).
La complessità sinfonica della vicenda invita alla rilettura del modello, “I Buddenbrook” di Thomas Mann. Il quartiere di Nişantaşı rimanda a Lubecca, il commerciante Cevdet al commerciante Johann, il Refik nervoso lettore delle Confessioni di Rousseau al Thomas Buddenbrook consultatore insoddisfatto del Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Ma le somiglianze fanno in ultima analisi risaltare una fondamentale differenza: il romanzo di Mann racconta il declino di una famiglia e di un mondo, quello di Pamuk, la sua ascesa, per quanto tormentata e drammatica.
La parola centrale del romanzo è perciò nişan, ‘bersaglio’. Ogni personaggio cerca di individuare il suo ed è dunque proiettato in avanti. Nel testo la parola ricorre in vari contesti, a riprova del maestoso controllo che Pamuk ha della sua lingua e che talvolta nella traduzione italiana si scioglie in una scorrevolezza facile e “amica del lettore”, a cui si è del resto offerto un romanzo storico senza corredarlo di note, perché non si affatichi.
Il cognome che (per legge, nel 1934) si è scelto Muhittin è Nişancı, perché il padre in guerra era appunto “bersagliere”, fuciliere scelto. Ciò spiega la sua battuta in uno dei tanti momenti di sconforto: sarebbe stato più giusto scegliere Nişancıoğlu, “figlio del bersagliere”, visto che non so cosa fare della mia vita (p. 327). I fidanzamenti, falliti o a buon fine, che coinvolgono molti personaggi, rammentano che in turco l’anello di fidanzamento si chiama “anello del bersaglio”.

E, infine, va ricordato che la villa di Cevdet, centro ideale della vicenda, è nel quartiere di Nişantaşı, che significa “pietra del bersaglio”, perché i soldati ottomani andavano in quella zona, prima che divenisse residenziale, per esercitarsi al tiro. Se non tutti i suoi personaggi, l’autore ha di sicuro centrato il suo obiettivo, collegarsi alla grande tradizione del romanzo europeo, ma esplorando l’anima della nascente borghesia turca. Oltre che a Mann, Pamuk si è infatti ispirato ai russi dell’Ottocento, ricostruendo ad esempio certe febbrili riunioni politiche in cui è coinvolto Muhittin a partire dai Demoni dostoevskijani, o donando al Refik aspirante riformatore del sistema agrario l’afflato del Levin di “Anna Karenina” (Refik è un Levin fallito).
L’operazione artistica trova inoltre interessanti paralleli cinematografici con il contemporaneo Fanny e Alexander (1982) la grande saga familiare in cui Ingmar Bergman rielabora gli anni della propria infanzia e “Amore e guerra” (1975) di Woody Allen, omaggio parodico ma dolente a Guerra e pace. Come Allen e Bergman, Pamuk prende come materiale di base la propria vita interiore, pur strutturando la sua opera su modelli preesistenti. Ne è prova La valigia di mio padre, il discorso pronunciato nel 2006 a Stoccolma in occasione del premio Nobel: la dialettica tra Pamuk e suo padre la troviamo già tra Refik e Muhittin, ovviamente modificata dall’arte romanzesca.
E Pamuk stesso è in tutti i personaggi di Cevdet, ma platealmente è in Ahmet, il figlio di Refik, aspirante pittore nel 1970, che legge il diario del padre senza capirlo nell’intimo. Alla fine, però, “in ascesa”, al contrario di Hanno Buddenbrook che muore di tifo e mette fine alla sua dinastia, entra nella sua stanza e comincia a lavorare.
Originariamente questa recensione era uscita su “Alias – il manifesto”.