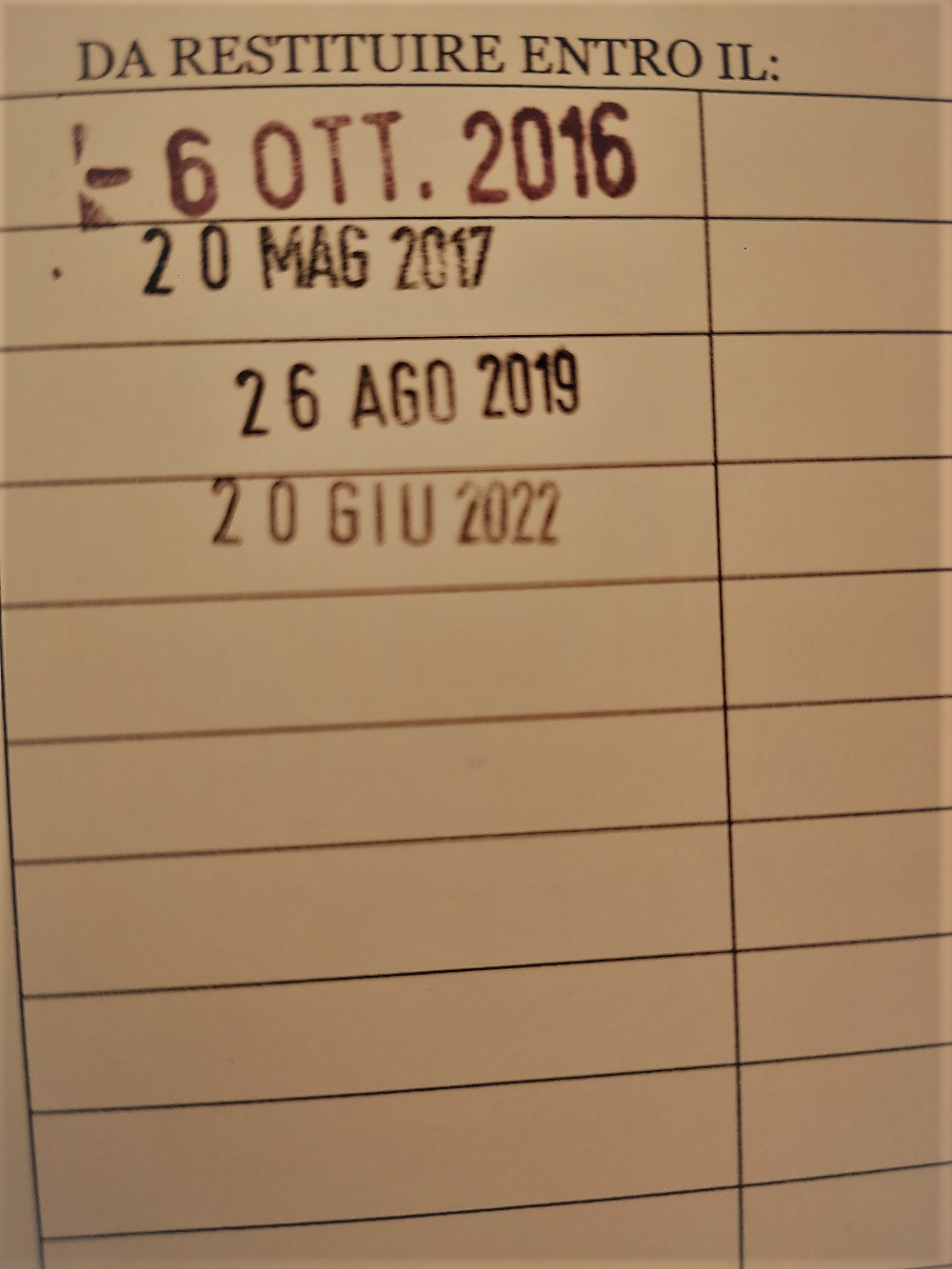Joyce a Roma
James Joyce e Roma: non proprio un colpo di fulmine (leggendo capirete!). A questo curioso rapporto è dedicato il bel saggio di Enrico Terrinoni – “Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma” (Feltrinelli).
Tre truffe ad Ancona – “lurido buco: sembra un cavolo marcio” – e una notte passata all’addiaccio con la compagna Nora e Georgie, il figlio di tredici mesi. Il viaggio da Trieste a Roma di James Joyce non ha proprio la fascinazione del Grand Tour intellettuale. Piuttosto una puntata di “Le iene” sul malaffare di cambiavalute, vetturini e impiegati ferroviari, a inizio secolo.
Ancora un po’ d’Umbria ed ecco Joyce proseguire il suo esilio volontario dall’Irlanda nella capitale del Regno, è il 31 luglio del 1906. Seguono 7 mesi e 7 giorni di vita romana, dall’afa estiva alla neve, che possiamo ricostruire attraverso le lettere al fratello Stanislaus (Stannie) rimasto a Trieste all’insegna di un accudimento economico e psicologico a distanza del grande scrittore che ha allora all’attivo una raccolta di poesie accompagnata da tante disillusioni editoriali ma sta raccogliendo i racconti “Dubliners” e si appresta a scrivere il libro che lo eternerà, l’Ulisse.
Queste giornate le racconta il bel saggio di Enrico Terrinoni – “Su tutti i vivi e i morti. Joyce a Roma”, uscito per Feltrinelli, rivelando quanto la permanenza apparentemente minore, anche in termini di tempo, abbia influito sulla sua opera maggiore.

Mentre è nota, infatti, la relazione tra lo scrittore irlandese dell’Odissea novecentesca e Trieste, in cui trascorse salvo questo periodo ed episodici ritorni in patria dal 1905 al 1920, meno si è scandagliata l’influenza capitolina sul suo lavoro successivo. A partire dal dramma “Exiles” dove la Capitale è scenario certo ma in tutta la sua opera.
Si sa che Joyce andò a Roma per lavorare in banca, ma non sulla base di competenze economico-finanziarie quanto della stretta relazione con le lingue che gli consentirono di lavorare per i primi mesi a stilare e tradurre lettere commerciali.
Enrico Terrinoni, che è titolare della cattedra di Letteratura inglese presso l’Università per stranieri di Perugia e insegna Traduzione all’Università Iulm di Milano, si è misurato con James Joyce traducendo e curando le sue opere più complesse come “Ulisse” appunto, e il libro definitivo dell’oscurità, il “Finnegans Wake”, oltre alle “Lettere e saggi”.
Qui il corpo a corpo con la vita dell’irlandese si fa ricerca di nessi biografici e corrispondenze numeriche fino quasi alla paranoia e ai ricettacoli teosofici della memoria del mondo: si tratta solo di tirarli fuori e a Terrinoni dobbiamo questa minuziosa opera di scavo e svelamento.
L’autore del capolavoro del flusso di coscienza, l’Ulysses – di cui il 2 febbraio sono ricorsi i 100 anni dalla pubblicazione -, arriva a Roma sull’onda di un’idiosincrasia ormai consolidata per la corrotta “C.C.R. (Chiesa Cattolica Romana)” – la stessa che lo aveva fatto fuggire dalla grande influenza che essa produceva a Dublino.
Ma a Roma c’è anche la traccia di quello che per altro verso lo affascina: Giordano Bruno, intanto, ma pure Gioacchino da Fiore. Religiosità laterali che danno fiducia alla sua visione del mondo non “allineata” e tormentata dal senso del peccato ma affascinata della mistica.
Nel libro si succedono le case romane di J.J.: Via Frattina 52 – dove anni fa fu apposta la targa del suo passaggio –, via di Monte Brianzo 51 (vicino alla prigione dell’amato filosofo Bruno, quasi un suo transfert personale, una connessione di destino), tra le due delle pensioni per riparare allo sfratto inatteso e subito come un torto.

Ma “Roma fu per Joyce – come racconta Terrinoni – una città di fantasmi, di spettri del passato che tornavano a infestare un presente incerto e minacciavano ogni idea di futuro, a dispetto di tutte le grandi intenzioni e aspettative di quando partì da Trieste”.
Lo terrorizza in particolare il Tevere che si unisce a due sue paure consolidate: cani e fulmini (come si diceva: un colpo di fulmine al contrario!). Ma è tutta l’atmosfera romana a suscitare il nesso traumatico tanto da suscitargli il racconto “I morti” e da riattizzare le fiamme dell’eterno conflitto materia e spirito, corpo e anima.
Il 25 settembre 1906 guarda i Fori da una panca di pietra e scrive “Roma mi fa pensare a un uomo che si mantiene esibendo ai turisti il cadavere di sua nonna” e riconosce di essere stato troppo duro con la sua Dublino.
Al fratello, che sempre lo incoraggerà a rimanere nella città, confessa la coincidenza tra un appetito smodato e gli incubi notturni e sembra quasi che le due cose avessero una correlazione come a dire di un Urbe bulimica. Nei sogni veri è James stesso l’assassino e, in quelli ad occhi aperti, riemergono il sospetto tradimento della moglie e lo spettro della gelosia che lo corrode a distanza oltre all’ossessione per la morte e il parricidio.
Eppure, furono persino allegri i giorni a Roma di Joyce ubriaco a ballare, ad esempio a fine permanenza, con due postini tra gli alti alberi e i busti del Pincio. Nota è l’amicizia con il Signor Pace, di giorno impiegato al Ministero delle Finanze e di sera gestore della trattoria a Monte Brianzo dove l’irlandese si ristora. L’ultima sera romana – a rischio di non avere i soldi per il ritorno a Trieste – andò anche peggio e J.J. finì per essere derubato uscendo da un bar ubriaco.
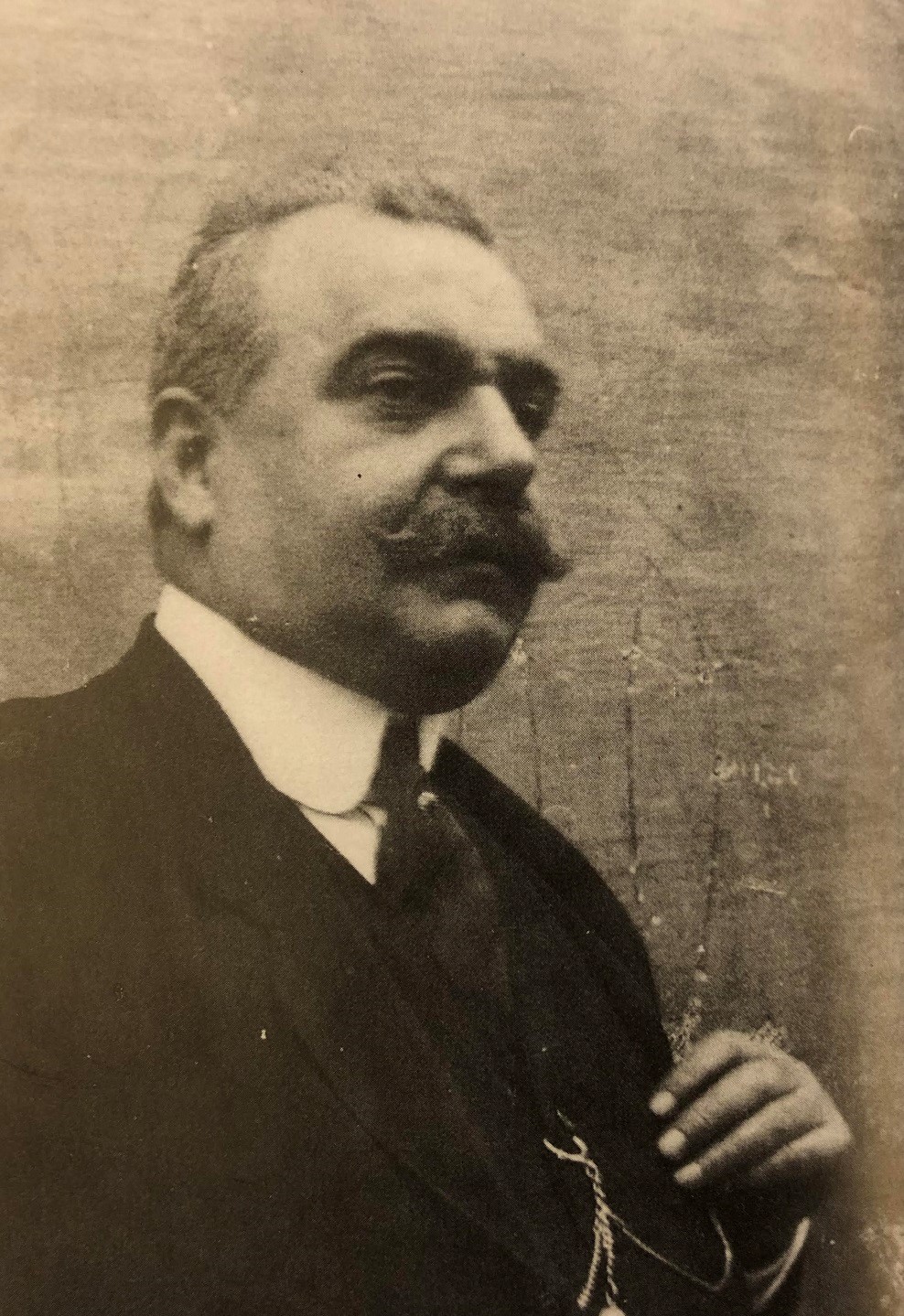
Il 15 agosto Joyce sale in cima a uno dei pochi omnibus a cavallo rimasti e va da Termini al Verano poi finisce anche qui tutto in vino. A novembre dalla sua scrivania d’ufficio sente esplodere una bomba con gran fragore.di cocci al caffè Aragno “sull’angolo del nostro palazzo”, poi una a San Pietro salta poco prima di una sua visita. Un giornale dell’epoca l’aveva anticipato in una lettera a firma “Il Bombardiere”.
Nella Roma di insurrezioni anarchiche e anticlericali, Joyce si appassiona al partito socialista italiano e alle sue tesi scoprendo una vocazione politica. Come scrive Terrinoni “dopo Roma, “scrivere politicamente” sarebbe stato per Joyce un punto fermo”. Ed è curioso che l’unica foto romana di Joyce – come racconta Carlo Bigazzi curatore di una mostra e un catalogo di anni fa (a cui dobbiamo le immagini dell’articolo) – sia un raduno di anarchici sotto la statua di Giordano Bruno in cui, a un ingrandimento professionale, si potrebbe rivelare il suo cappotto bianco. Non male per il maestro dell’epifania no?

Ma, alla fine, dalla Roma casa (Rome/Home è solo uno dei tanti giochi di parole joyciani rintracciati da Terrinoni) e cimitero che impantana e trasforma tanto da suggerirgli l’idea dell’Ulisse, sembra dirci Joyce, si deve e si può solo scappare.