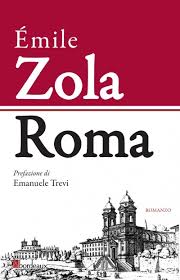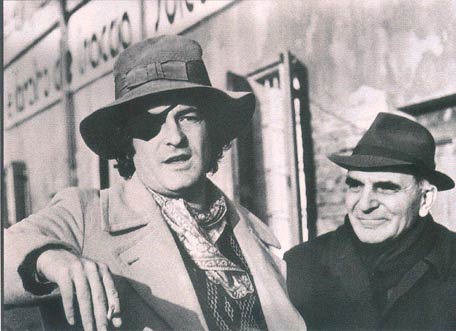11 febbraio 2013
Ci sono stati giorni in parte esaltanti per un cattolico. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Alla fine, del gesto dimissionario e “debole” del papa precedente sono rimasti la simpatia che ispira l’umano – in realtà non era stato il punto forte dell’austero teologo bavarese – e, per molti, tanti legittimi sospetti che gra(va)vano sul dietro le quinte vaticane. E un modo di dire che porta ora una data di scadenza: morto un papa… Come è che finiva?
Così, mentre un elicottero sfumava quelle perplessità verso la residenza lacustre e secondaria di Castel Gandolfo, a Roma erano restate le beghe e le porpore. La necessità di un segnale forte che spazzasse via tanto imbarazzo e riportasse al centro della questione l’attesa moralità (il Vangelo, anche se in una forma teologale, già c’era) di una Chiesa che aspira a essere la bilancia giusta e confidente del mondo della fede.
Scrive Salamov nei suoi bellissimi racconti in romanzo della Kolyma: “Lo scrittore scrive nella lingua di coloro a nome dei quali parla. E nulla più. Se conosce troppo bene il soggetto, la gente per la quale scrive non lo capirà. In questo caso lo scrittore avrà tradito, sarà passato dalla parte del proprio soggetto”. E conclude: “Non bisogna conoscere troppo bene l’argomento di cui si scrive”. Molti autori hanno raccontato Roma meglio di altri che vi sono nati. È il caso, ad esempio, di Émile Zola e del suo “Roma” meritoriamente ripubblicato dalle edizioni Bordeaux, con grande cura e l’introduzione di Emanuele Trevi.
Scrive il grande autore transalpino a proposito della Chiesa capitolina: “Il suo è d’altronde il pensiero secolare del papato, la conquista di tutte le anime: Roma centro e signora del mondo. Non ha che una volontà, uno scopo: lavorare all’unità della Chiesa, ricondurre a lei le comunità dissidenti per renderla invincibile nella lotta sociale che si prepara”. La stagione che vive Zola e il suo personaggio, l’abate Pierre Froment, è quella dell’autunno del 1894 in cui lo scrittore francese passa cinque settimane nella nostra città. Tanto da poterla raccontare con uno sguardo, per ritornare a Salamov, così laterale da finire per essere centrale, appropriato, fedele al soggetto. Zola raccoglie appunti sugli intrighi vaticani e le sue gerarchie. Come scrive Trevi nelle pagine che precedono il corposo libro, “anima pura e ardente” Pierre parte per Roma per incontrare il papa faccia a faccia cercando di “accordare gli ideali della carità cristiana e della giustizia sociale”. La chiesa, come qualsiasi confessione rigidamente statuita, ha da sempre questa tara: non far sentire il peso dell’impalcatura che si è costruita addosso e intorno per funzionare secolarmente e universalmente. Non far percepire l’invalicabilità di questo muro, farlo sciogliere dinanzi all’afflato del credente e del credo, dell’uomo di fede in abiti talari e non, del libro che li ispira con principi talmente larghi e integrali da richiedere una continua lotta tra umano e divino. Ed è una tara difficile da sfumare ma necessariamente destinata e comandata al venir giù per non rendersi il parlamento lontano dall’interesse generale del bene di base che la fa stare.
L’esaltazione dei giorni della fine del pontificato di Benedetto XVI nasceva da qui: dalla speranza – per qualcuno dall’improrogabilità – di un segnale che cancellasse in un conclave, una fumata bianca, un bagno purificatore le ombre della storia passata e presente riportando al centro della questione – lo scrivo con la necessaria umanità e distanza dalla fede che, parafrasando Salamov, è forse la via per avvicinarsi al soggetto senza tradirlo – lo scopo ultimo di qualsiasi macchina: fare quel che deve fare, per il bene di chi fu costruita, ovvero il bene di chi la fa funzionare e di chi la tiene in piedi avvalorandone il senso definitivo.