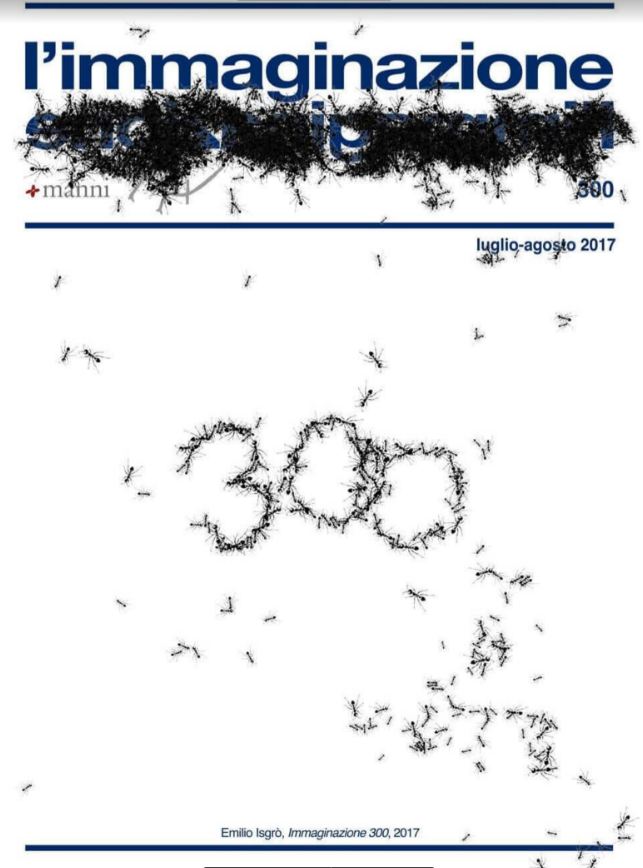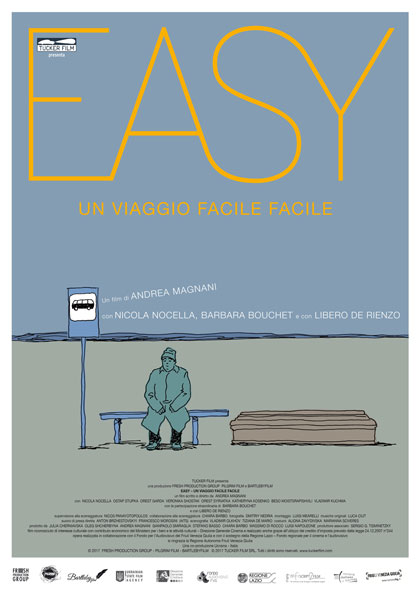Ou Ming
C’era una volta Ou Ming. Per la serie dei ristoranti perduti.

OU MING – Via Francesco Crispigni
A Roma, in via Francesco Crispigni, là dove c’era «Ou Ming», c’è oggi una trattoria che ostenta fin dall’insegna l’attenzione alla tradizione italiana. Mi sono chiesto se non ci sia, in questa scelta, la volontà di sottolineare la discontinuità con il ristorante precedente. Come a dire: basta con la gastronomia cinese, torniamo a mangiare la nostra cara vecchia tradizionale cucina italiana. È strano perché per me, come per moltissimi altri che hanno vissuto nel quartiere Portuense dagli anni Settanta agli anni Novanta, Ou Ming era un ristorante dove si andava abitualmente e con soddisfazione.
Fu il primo ristorante cinese di zona e – dopo le inevitabili diffidenze iniziali – diventò una scelta frequente per tranquille cene fuori, da alternare insomma alla classica pizzeria o alla trattoria. Dunque, nella mia personale tradizione gastronomica (così come in quella di molti altri, immagino) ci sono sì i bucatini all’amatriciana e la pizza capricciosa, ma ci sono anche gli involtini primavera e il maiale in agrodolce. E il posto in cui li ho mangiati per la prima volta è stato proprio Ou Ming, il ristorante perduto di cui parlerò oggi.
Ma prima una digressione, meno estranea al tema di quanto si possa pensare: uno degli atteggiamenti del prossimo che più mi gettano nello sconforto è lo sciovinismo gastronomico. La convinzione che la cucina italiana sia la migliore del mondo, ostentata da persone che non ne hanno mai provata altra. Quando torno dai miei viaggi in giro per il mondo sento chiedermi spesso: «Siete stati lì? E per mangiare come facevate?» (la migliore risposta, un po’ antipatica, ma efficace se si vuole troncare la discussione è: «con la bocca»). Ma la vera domanda da porre agli irriducibili fedeli dello spaghetto è: perché scegliere? La gastronomia non è un coniuge, è un amico. È possibile, anzi è bello, averne più d’uno contemporaneamente. Ringraziando il cielo mangiamo tre volte al giorno tutti i giorni. Perché abbonarsi alla cucina italiana per tutta la vita?
Si può tranquillamente fare colazione con i pancake, pranzare con i rigatoni alla carbonara e cenare con una zuppa di miso. Ecco, i ristoranti cinesi in Italia avranno anche i loro lati oscuri, e la qualità della cucina è in genere quella di una rosticceria/tavola calda, ma se un merito va loro riconosciuto è stato quello di aver contribuito a sgretolare il provincialismo culinario.
All’epoca della loro diffusione, i ristoranti cinesi a Roma furono, per noi ragazzi che cominciavamo ad andare a cena fuori senza genitori, con gli amici o con la ragazza, un’ottima occasione: si spendeva poco (spesso meno che in pizzeria) e si mangiava in un ristorante “vero”, con camerieri estremamente cerimoniosi, begli arredi, luci, acquari. Si potevano ordinare alcolici senza spendere una fortuna e alla fine la grappa ti veniva offerta (in genere, anche se noto che questa usanza si va perdendo, il cameriere cinese al momento del conto portava a tavola anche piccoli regali: un calendario pieghevole, un portachiavi, un soprammobile. Tutte cose orribili e inutilizzabili, ma che rafforzavano l’idea che andando a mangiare lì si facesse un affare).
Ou Ming fu il primo e tenne a battesimo me e molti dei miei coetanei. All’epoca del suo massimo splendore entrambe le sale erano affollate. C’era quella antistante, a cui si accedeva direttamente dall’entrata, e poi un’altra, dietro, ancora più grande, dove trovava posto il tavolo circolare con al centro il piano di legno girevole per permettere a ogni commensale di servirsi con comodità. Nel tempo la clientela è diminuita e le ultime volte che sono andato da Ou Ming la sala con il tavolo circolare era sempre chiusa, le luci spente, il grande tavolo tondo inutilizzato.
Eppure è stato lì che tutti siamo stati svezzati, imparando che lo spericolato accostamento del salato con il dolce non era possibile solo nella rassicurante forma del prosciutto col melone, ma anche del maiale con l’ananas. Abbiamo tutti dovuto ammettere che le alghe, fritte, erano buonissime, e che i ravioli al vapore, che uscivano fumanti dal cestello di bambù con una larga foglia di verza a fare da piatto, erano squisiti (ancora una volta: senza farsi troppe domande sulla composizione del ripieno).
Ecco, non sono un fissato della cucina cinese, ma i ravioli al vapore fanno sicuramente parte del mio catalogo di piatti preferiti. Ogni tanto sento il bisogno fisico di mangiarli. Ho provato a rifarli a casa, ma la preparazione dell’involucro di pasta mi ha creato qualche difficoltà. Mi piacerebbe che ci fossero dei fast food cinesi nella mia città, dove poter entrare al volo, sbafarsi quattro ravioli al vapore con un filo di salsa di soia, e poi uscire senza dover ordinare un intero pasto.
Nel corso degli anni, a Roma, nuovi ristoranti cinesi sono sorti con frequenza impressionante. A voler essere pedanti bisognerebbe specificare che si tratta di ristoranti cantonesi. La gastronomia cinese, infatti, è estremamente articolata. I piatti cinesi che noi italiani siamo abituati a mangiare nelle nostre città sono quasi esclusivamente cantonesi e come gusto e preparazione sono sensibilmente diversi da quelli dello stile Szechuan, ad esempio, o dalla cucina di Shanghai.
Si andava da Ou Ming, spesso portando qualcuno che metteva piede in un ristorante cinese per la prima volta. Si ostentava dimestichezza, assolutamente infondata, con questa gastronomia esotica. Si davano consigli. C’era sempre quello più svelto di tutti, che aveva già imparato a mangiare con le bacchette. Poi, al tavolo accanto, qualche spericolato chiedeva: «ma non si può avere un po’ di pane?» e improvvisamente piombavamo, tutti, in un film di Fantozzi.