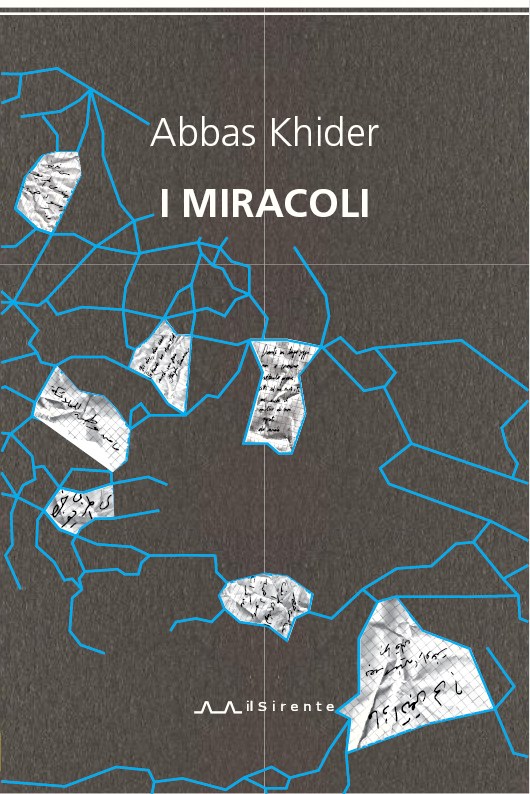Roma regina lasciva
Roma regina lasciva. Così l’esordiente Edoardo Zambelli (Cassino, 1984) in “L’antagonista” (Laurana) racconta la città che si apre davanti al protagonista all’arrivo della stazione dopo un viaggio in treno da Gonzaga. Sulle tracce dell’ex Erika, che ha scelto di farla finita. In mezzo c’è un lavoro di critico cinematografico, la lettura di classici imprescindibili della letteratura e tanta strada ferrata. Verso Torre dell’Orso e di nuovo ancora a risalire.
Roma si offrì ai miei occhi come una regina lasciva. Le luci dei lampioni, gli ingorghi di macchine e gli schiamazzi l’avvolgevano come un abito da sera. Dappertutto i volti incantati di turisti stranieri. Anche di sera, anche d’inverno.
Come ogni gran donna sapeva negarsi e concedersi. La serale maestosità del suo apparire era appannata solo dalla certezza, negli occhi di chi la guarda, del suo nascondersi. Un’altra Roma vibrava da qualche parte. Violenta, selvaggia, sacrilega.
Non l’avevo mai vista così. Per me Roma era sempre stata una visione estiva. Una violenta sinfonia di voci racchiusa in una bolla d’umidità. Nel corso della mia vita c’ero stato una decina di volte in tutto. E sempre di passaggio, mai per più di tre o quattro giorni. L’ultima volta era stata per un festival di cinema horror. In particolare, c’era una retrospettiva sul cinema di Mario Bava.
Mi fermai per un paio di giorni. Quando finii di vedere il primo film, I tre volti della paura, uscii dalla sala di proiezione per fumare una sigaretta. Telefonai a mia moglie. Stava lavorando, fu una telefonata breve. Mi chiese come
stava andando, le avevo detto bene. Niente di più. Alla fine mi disse che mi amava e che doveva chiudere. Chiudemmo.
Ora, fissando Roma dal finestrino del taxi, mi chiesi se già allora si era innescato qualcosa. Se il cancro che ci avrebbe divorati di lì a poco stesse già creando metastasi nel nostro rapporto. Domande inutili. Non sarebbe cambiato nulla in ogni caso.
Cercai di concentrarmi ancora sulla città. Mi tornavano in mente i film di Fellini che avevo visto da ragazzo, e i volti degli attori che avevano dato una forma umana, una voce alla città.
Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello Mastroianni e innumerevoli altri. Soprattutto Mastroianni, per me. Non era nato a Roma, ma ci aveva vissuto quasi tutta la vita. Fino a diventare anche lui un’incarnazione della capitale. Le sue scorribande notturne per via Veneto ne La dolce vita sono le immagini che per più tempo hanno rappresentato Roma ai miei occhi. Ma non erano solo i film e le maschere degli attori.
Erano anche le violente rappresentazioni borgatare di Pasolini conosciute ai tempi dell’università. I ragazzi di vita, l’oscura vitalità delle borgate. Tutto questo mai visto, solo immaginato. Eppure fondamentale nella costruzione del mio immaginario sulla città.
Una volta uscito dalla stazione e messo piede nel taxi, sapevo che si era appena realizzato un distacco definitivo. Mi ero lasciato Gonzaga alle spalle. Ero passato dalla città della mia giovinezza a quella che ora vedevo come la città della verità. Ripensai a Conrad. Avevo attraversato la proiezione della mia
linea d’ombra.
Il tassista non la smetteva di più parlare. La sua voce mi aggrediva di continuo. Una voce ruvida, sgarbata. Dal sedile posteriore ne vedevo solo la nuca, sudata nonostante la bassa temperatura. Il busto, ricoperto da molli strati di lardo, sobbalzava a ogni buca. Indossava una polo grigia, con ampie chiazze di sudore sotto le ascelle, e teneva un braccio attorcigliato sul poggiatesta del sedile a fianco.
Un sottile lezzo stagnava nell’abitacolo. All’inizio mi era sembrato quasi insopportabile, poi mi ero lentamente abituato. Aprire il finestrino e tenersi lontani dalle ascelle del tassista aiutava.
Gli avevo dato direttamente il foglio che mi aveva stampato il cugino di Erika. Speravo di evitare conversazioni. Così non era stato. Anche se, in realtà, non si trattava proprio di una conversazione. Parlava da solo. Si rivolgeva a me come se fossi un interlocutore muto. Come se il suo intero parlare fosse una gigantesca domanda retorica che non aveva bisogno di replica. Meglio così. Era comunque fastidioso, ma per lo meno non ero costretto a parlare. Rendeva il tutto più sopportabile.
Immagino sia il modo che certe persone hanno per esorcizzare la noia del proprio mestiere. Trasportare gente da un posto all’altro per un’intera giornata non deve essere una cosa particolarmente eccitante. E quindi si è spinti a cercare un contatto. Una scintilla di umanità. A parte il tanfo e le chiacchiere, il viaggio era scorrevole.
Non avevamo incontrato eccessivi ingorghi. Qualche sporadico rallentamento e nulla più. Il teatro di Eugenio Alberti si trovava a Trastevere. Non impiegammo più di una mezz’ora per arrivare a destinazione. Il tassista si fermò, lasciandomi all’imbocco di una stradina tanto stretta da impedire al taxi di proseguire. Mi rassicurò, ero a pochi passi. La via era quella, avrei solo dovuto cercare il numero esatto.
Lo ringraziai. Gli chiesi se avesse mai sentito parlare di un teatro in quella zona. Non ne sapeva nulla. Roma è piena di teatri, magari ce n’era uno anche lì. Il suo ragionamento non faceva una piega. Pagai e uscii dal taxi. Avevo lasciato la mia roba al deposito bagagli della stazione, di modo da potermi muovere più agevolmente nel caso ci fosse stato da camminare un po’.
Il taxi si allontanò velocemente. Mi tirai su il bavero della giacca. Tirai fuori il pacchetto di sigarette e ne accesi una. Mi guardai un attimo attorno. Nessuno in strada. Anche i rumori della città si erano trasformati in un’eco lontana. Nel tragitto in taxi la città si era mostrata ancora nel pieno dell’attività. Ora invece pareva essere notte fonda. Suggestione, pensai.
Controllai il numero civico che dovevo cercare, poi mi incamminai. I pochi lampioni che illuminavano la via gettavano una luce giallognola, in qualche modo evocativa di una malattia. Mi pareva assurdo che in una via tanto stretta, da qualche parte, potesse esserci un teatro. La strada era bagnata. I bordi erano chiazzati da macchie di urina che esalavano un odore malsano. Da qualche parte mi sembrava di udire un ronzio confuso, forse televisori accesi. Qualche mormorio fugace. Avevo quasi l’impressione di essere osservato. Guardando in alto, vidi che le imposte delle case erano tutte chiuse. L’intonaco sulle pareti dei palazzi antichi era scrostato e stinto dal sole. Era come camminare nelle budella della città.
Come cadendo in un imbuto, i miei pensieri andavano via via focalizzandosi su Alberti e su ciò che avrei dovuto dirgli. Ancor più, su ciò che lui mi avrebbe risposto. La presenza di Erika in quel luogo era quasi palpabile. Quante volte aveva camminato per quella strada, magari in mezzo a un folla di giovani artisti e intellettuali diretti al teatro di Alberti? Molte. Era uno dei luoghi in cui aveva vissuto e che l’avevano vissuta. Questo mi metteva addosso una strana ansia. Finita la prima, accesi subito un’altra sigaretta. Intanto, la via sembrava allungarsi sempre uguale, all’infinito.
Non saprei dire per quanto tempo ancora andai avanti a camminare. Alla fine, trovai il numero che stavo cercando. Una fila di quattro saracinesche, serrate, e un alto portone in ferro. Accanto al portone, i cadaveri sovrapposti di vari manifesti ormai distrutti e ingialliti. Se un tempo era stato un teatro, evidentemente non lo era più. Era difficile dire però che cosa potesse essere adesso. Al di sopra del portone, si vedevano due ampie finestre. Da quel che potevo intravedere, all’interno era tutto buio. C’era un citofono. Eugenio Alberti. Senza esitare troppo, suonai.