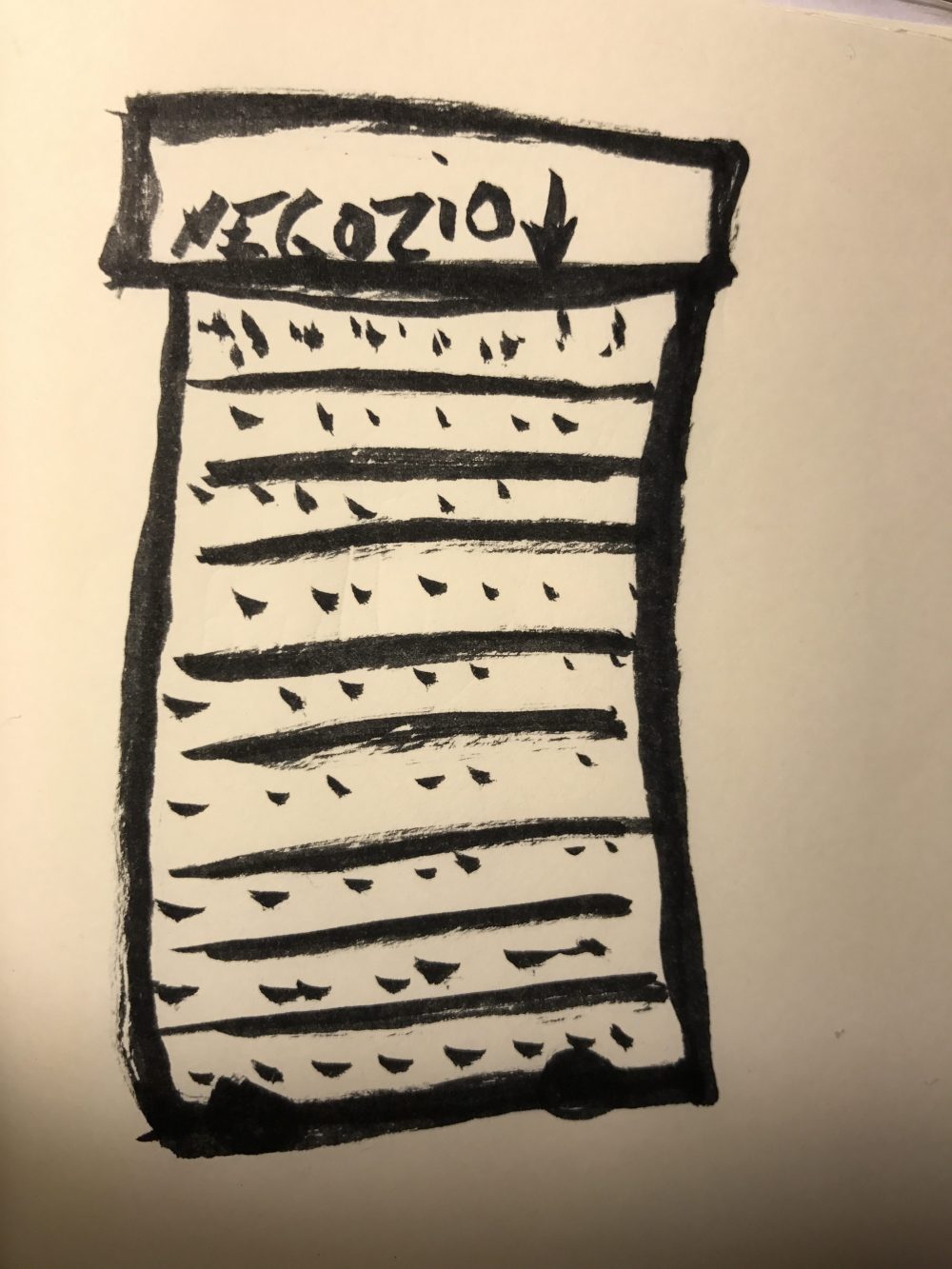
La misteriosa persistenza dei negozi di periferia
La misteriosa persistenza dei negozi di periferia. Un racconto.
Ci sono negozi di periferia per i quali il termine “esercizio” non ha solo valore di sinonimo ma funziona anche nel suo significato parallelo di addestramento per raggiungere l’assuefazione.
L’attività commerciale è qui un’attività di resistenza. Negozietti, baretti, mini-market. L’onnipresente diminutivo sembra proteggere questi esercizi dallo scontro impari con le grandi catene, i franchising e le vendite online. Al centro della città non avrebbero chance. In periferia, misteriosamente, sopravvivono.
Passo davanti a una macelleria di Monteverde. Il locale all’interno è buio. Ricorda le sagrestie di certe chiese ottocentesche. A separare il negozio dalla strada è una di quelle tende a fettucce con tasselli colorati incastrati tra loro, un manufatto che potrebbe provenire indifferentemente da un baule di anticaglie come da uno scaffale del negozio di cineserie accanto.
Ma più che l’arredo è la mercanzia a stupirmi. Due o tre trozzi di carne di qualità indefinibile giacciono direttamente sul lastrone metallico. Il banco-vetrina, così immagino si chiami, sembra quasi il negativo di una foto degli sfavillanti banchi macelleria dei centri commerciali. Qui è tutto grigio. Nessun neon a ravvivare il rosso delle membra, né trecce di peperoncini o di alloro a fare da cornice fiamminga. Prima ancora di farmi domande sull’igiene mi faccio domande sull’appetibilità. Chi mai può desiderare quelle lombatine livide, quelle fettine?
Nel frattempo il macellaio e l’unica cliente, immersi nella penombra, si sono accorti della mia presenza al di là del vetro. Lui mi guarda con sospetto e forse con una punta di risentimento, quasi leggesse i miei pensieri. Potrei a questo punto contrattaccare, entrare e chiedere se hanno del manzo kobe o una bistecca di bisonte. Ma non vorrei – come in un recente romanzo di Stephen King – che quel negozio fosse l’ingresso di un varco spazio-temporale. Non vorrei, attraversando quella penombra, trovarmi trasportato indietro negli anni Sessanta.
Una penombra simile colora il baretto della Magliana dove qualche mattina dopo mi capita di fare colazione. Qui, a richiamare la mia attenzione, è la vetrina-specchio che fa da fondale all’avvilito barista. Decenni di teorie di visual merchandising e shelf-marketing ignorate con indifferenza lasciano il campo a un cumulo di disordine. Là dove dovrebbero esserci vasi di vetro ricolmi di bonbon, irresistibili teorie di macarons multicolore, bottiglie di superalcolici di grido illuminate da sapienti faretti c’è solo l’accatastamento di scatole di cartone.
Una fiala di liquore rossastro – probabilmente un alchermes che non ha mai conosciuto il brivido del versamento in coppa – fa timida mostra di sé dietro un cofanetto con decorazioni liberty.
A portata di mano del barista solo lo stretto indispensabile: il vassoio con i cornetti (unica concessione all’età contemporanea: il “vegano con miele integrale”), la buatta con le bustine di zucchero (canna, semolato, dolcificante), le leve della macchina cromata per il caffè che da sempre conferiscono un’aura steampunk ai bar di ogni latitudine, prima ancora che il genere prendesse piede.
Anche qui forte la tentazione di chiedere qualcosa di spiazzante: un Irish coffee, una pasta di mandorla. Costringere l’avvilito barista a frugare tra quelle scatole abbandonate al riflesso della specchiera. Davvero, cosa conterranno? Le scritte riportano nomi di brand ormai fuori produzione da tempo. Ma anche stavolta cedo: “un cappuccino e un cornetto”, dico e l’avvilito barista – chissà se deluso o rassicurato – esegue.
Quando è stata l’ultima volta che avete pronunciato la parola “latteria”? Eppure c’è un bar, in zona Trullo, per il quale non esiste definizione migliore. Ci entrai una volta sperando di comprare un paio di tramezzini. La proprietaria – una signora anziana che in quell’ambiente così dimesso si pregiava di indossare un commovente camice bianco – mi rispose: “Tramezzini? No, noi non le facciamo quelle cose lì”. Neanche avessi chiesto un panino con pulled pork e salsa di rafano.
Infine, le mercerie. Altra struggente categoria di negozi di periferia che persiste misteriosamente e di cui continua a sfuggirmi la sostenibilità economica. Nel quartiere Portuense ce ne sono parecchie. Hanno un’atmosfera da biblioteca spagnola, scaffali di legno scuro, alte scale a rotelle che corrono lungo le pareti.
Qualche volta ci entro e capisco Jep Gambardella quando dice che la cosa che gli piace di più nella vita è l’odore delle case dei vecchi. Chiedo un nastrino. Con la scusa di quell’acquisto da pochi centesimi ho la possibilità di osservare per un po’ indisturbato l’unicità di quell’ambiente. Il lato interno del bancone, con sopra disegnate tacche e numeri, è un metro sempre pronto all’uso.
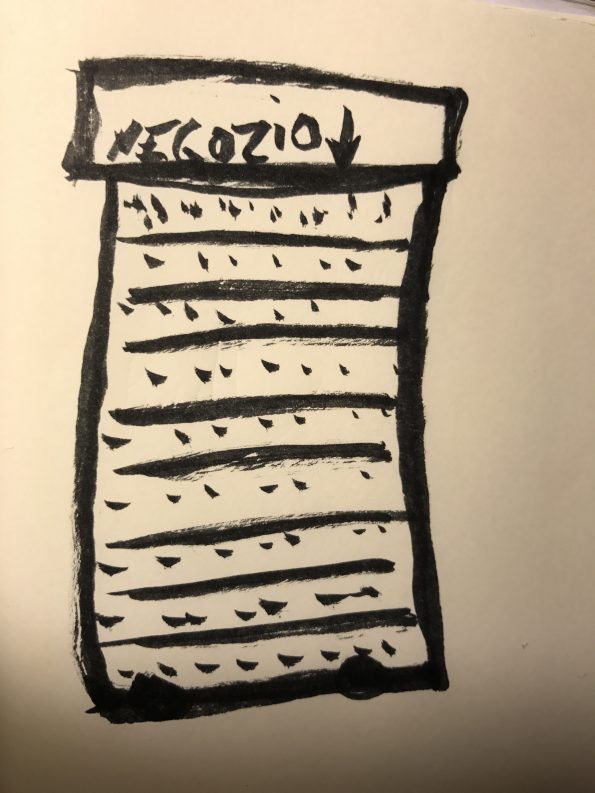
Pile di scatole di scarpe contengono bottoni di ogni forma e colore, campioni dei quali – appuntati con fili o colla – fanno mostra sul lato esterno dei contenitori.
Quando esco mi chiedo se il modo in cui acquistiamo le cose oggi è più longevo di quello del passato. Anche l’e-commerce è una bolla destinata a scoppiare? E i centri commerciali sono eterni o diventeranno un giorno scenografie per serie TV sulla fine dei tempi? I negozi di periferia queste domande non se le pongono. Loro sono come quegli asceti che vivono di niente, stiliti del commercio, calabroni che sfidano le leggi dell’aerodinamica di mercato. In realtà non potrebbero volare, ma loro non lo sanno e sono sempre lì.




