
Il campo di Zebio Còtal
Un campo da dissodare. E’ il campo di Zebio Còtal, contadino violento e alcolizzato. Una bella pagina di scrittura di paesaggio e agricoltura tratta dall’omonimo Zebio Còtal (rfb editore) di Guido Cavani. Un repechage di cui ora sentiamo più bisogno di prima.
Zebio Còtal è un testo di sorprendente lucentezza scritto da Guido Cavani un autodidatta – tipografo soldato e impiegato – e selfpublisher ante litteram modenese con precisione e freddezza di visione. In esso il mondo contadino – campagnolo lo avrebbe detto l’autore – vi è raccontato senza infingimenti o stondature.
Cavani ha grazia nel dolore, cosa non sfuggita a Pasolini che scrive “Guido Cavani non confonde la pietà con la compassione, non sostituisce l’indulgenza alla carità, non ci offre l’alibi di un atomo di bontà nel suo personaggio per persuaderci a ricordarne l’insopprimibile natura umana”.
Il romanzo è ambientato a Pazzano, nei dintorni di Serramazzoni (Serra, nel libro), appennino modenese (ma le pagine passano per Pavullo e Maranello e arrivano fino alla Garfagnana) e non lascia sfuggire la grazia di una scrittura che ha prodotto (autoprodotto in proprio, come si diceva) anche molta poesia.
Nell’edizione presente – che segue alcune scomparse dagli scaffali a partire dalla prima Feltrinelli del 1961 (inizialmente era stato stampato a sue spese nel 1958) – che ci auguriamo definitiva Omar Di Monopoli scrive di Cavani: “riesce con invidiabile finezza espressiva a costruire un’opera che parte come un robusto affresco naturalista per disvelarsi però, a piano a piano, quasi a tradimento, come l’apologia di una solitudine invitta e disperata”.
Vi offriamo, ringraziandone l’editore, un piccolo estratto.
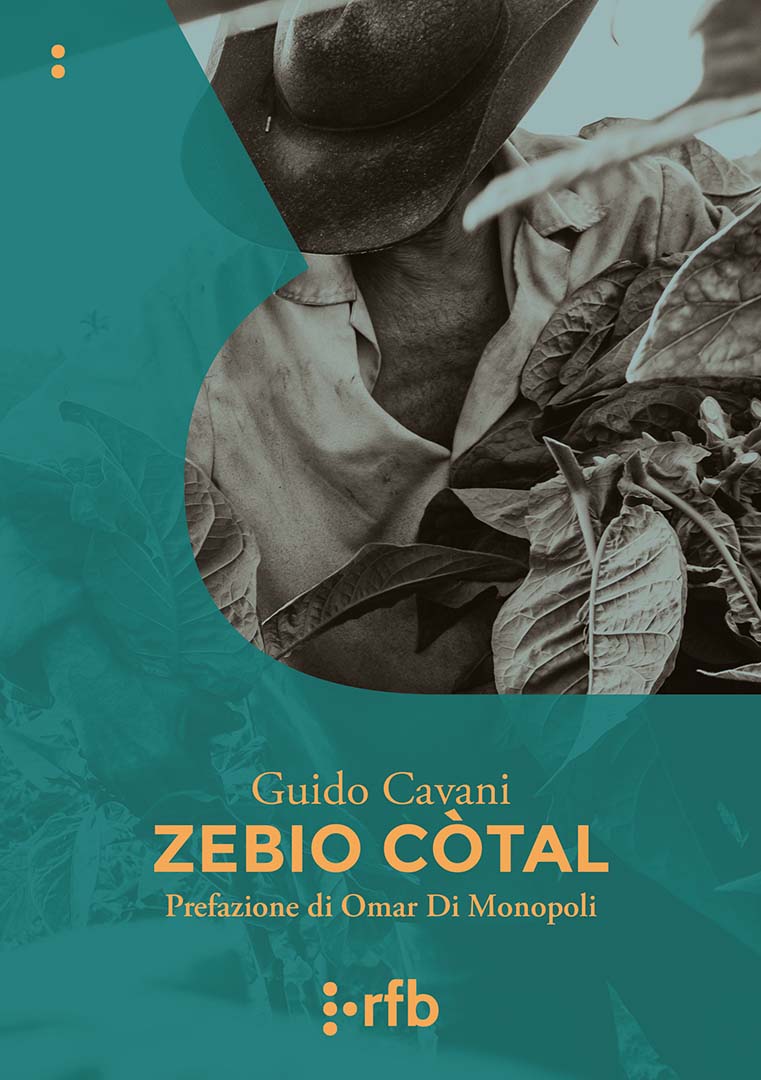
Il campo di Zebio Còtal distava dalla casa un duecento metri circa: era un lembo tondeggiante di terreno incastrato fra i calanchi, che scendeva fino al fiume; così ripido che non si poteva ararlo coi buoi, ma bisognava dissodarlo a colpi di zappa.
La terra era poca e le piogge ne portavano sempre via, nonostante che il contadino, dalla parte della brughiera, avesse sbarrato il margine con un muro a secco di sassi.
Le rocce in molti punti affioravano come le ossa sotto la pelle dei vecchi. Zebio lo seminava per tre quarti a grano e l’altro quarto lo coltivava a patate.
Il grano ci veniva su a stento; la pioggia lo spiantava, il vento lo
torceva in tutti i sensi, il sole lo strinava senza lasciarlo maturare. Anche le patate allignavano alla meglio.
Quella terraccia rossa, che quando pioveva diventava fango attaccaticcio e che quando seccava diventava cemento, non permetteva alle piante di radicare prima e di crescere poi.
Il campo aveva solo un albero in cresta, dove il terreno era più arido; un vecchio faggio contorto e rosicchiato dal vento, con tre rami in croce, su cui le foglie si contavano e facevano pensare alle ultime gocce d’acqua d’una fonte che sta per seccarsi.




