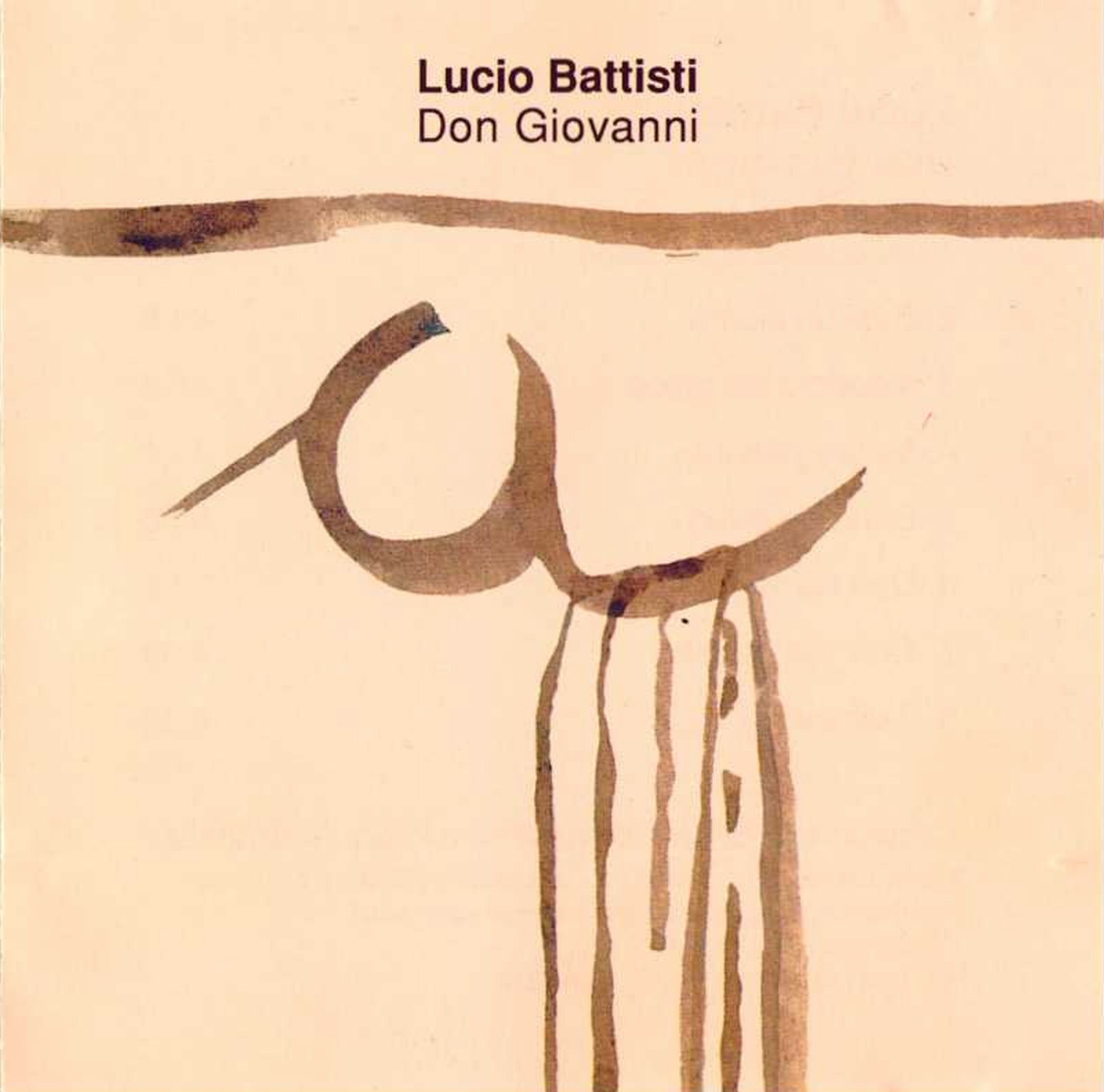Angela Zucconi
Angela Zucconi è un bell’incontro per chi ama Roma e anche per chi crede nel grande valore degli intellettuali a favore della gente – del popolo si sarebbe detto anni fa con ambizioni non populiste ma con sincera speranza nella compattezza di uno stato sociale. Purtroppo si tratta di esempi non “superati” ma purtroppo spesso “insuperabili”. Ecco perché la lettura di questo “Cinquant’anni nell’utopia e il resto nell’aldilà” (edito da Castelvecchi che ringraziamo per il corposo estratto) ha un grande valore di testimonianza.
Nel brano che vi apprestate a leggere si scoprono via Cola di Rienzo, l’Orto Botanico e un curioso incontro con Augusto Frassineti, la Ginzburg e l’Einaudi romana quella degli Uffici del Vicario, Bobi Bazlen, la vita delle borgate allora in trasformazione (Valmelaina e Tormarancio, Gordiani ecc.), lo spirito innegabile di una rivoluzionaria old (purtroppo) style. Se avrete voglia e tempo di leggere questa biografia colma di coraggio e forza civile scoprirete un’intellettuale non parolara, una donna di azioni (tante) e di azione sempre. Dai primi passi. E, dopo, non mai sugli allori. Interessantissime le battaglie civili per l’istruzione nell’Abruzzo chietino. Progetti che hanno, a sentirli oggi, la forza partecipativa di una mission senza calcoli di bilancio grazie alla quale questo è (e non vogliamo dire era) un Paese migliore.
Giochi proibiti
di Angela Zucconi
Bobi Bazlen era riuscito a restare a Roma durante l’occupazione tedesca.
Quando ci incontrammo e seppe che avevo un posto di insegnante
al liceo delle Suore di Nevers, mi procurò un lavoro per il
pomeriggio presso la casa editrice Einaudi in via Uffici del Vicario.
L’ufficio era sistemato in un appartamento molto signorile con un
buon odore di cera che mi ricordava quello della villa DanneskjordSamsoe
dove andavo a dare lezione di italiano a Copenaghen. Dovevo
rivedere le traduzioni e fare l’editing dei libri già in bozze di stampa.
Questo lavoro solitario, forse perché ero stanca della mattinata
passata a scuola, forse perché mangiavo poco, forse per l’ora pomeridiana,
certo è che mi dava un gran sonno. Cercavo di scuotermi e
con la scusa di chiedere qualche consiglio andavo a trovare in una
stanzetta silenziosa che dava su un cortile, Natalia Ginzburg, che allora
era soltanto la vedova di Leone. Natalia mi fece prendere (inutilmente)
confidenza con quel lavoro e mi fece fare amicizia con gli altri
redattori importanti, quelli che davano del tu a Giulio Einaudi e
frequentavano la sua casa. Pavese, Felice Balbo, Franco Rodano, Giolitti.
Alla fine della giornata di lavoro si andava qualche volta a bere
il vino in un’osteria vicino a Ponte Milvio.
Allora tutte le osterie appena fuori porta avevano un pergolato
come quello dove andavamo con Bobi Bazlen e il gruppo delle allieve
del liceo Nevers a cantare certe antiche canzoni francesi popolari
di cui Bobi aveva fornito i testi.
Un giorno prendemmo addirittura due carrozzelle per andare in
un’osteria dell’Appia antica e pagammo i vetturini con due forme di
pecorino prodotto dal ramo del «gruppo Nevers» che aveva terre e
soprattutto pecore nella Valnerina.
Con il gruppo di Einaudi invece si parlava di libri. Io come al solito
ascoltavo. Neppure con Natalia mi ricordo di aver mai parlato
di niente. Provavo per lei un senso di rispetto, e di riguardo per la
Angela con Natalia Ginzburg e seduta a lavorare
sua storia. Leone Ginzburg era morto sotto tortura alcuni mesi prima
a Regina Coeli.
Ma un giorno Pavese mi disse che Natalia stava male e aveva chiesto
di vedermi. Lei abitava allora a via Balbo in una pensione dell’Ywca
insieme alla madre e alla sorella di Leone.
Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Coeli. Davanti all’orrore
della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che
precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi, a
noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio sulla
neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e libero, ricco di desideri
appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il
tempo migliore della mia vita e solo adesso che mi è sfuggito per sempre,
solo adesso lo so.
«Perché l’hai fatto?». È la prima domanda disperata che si rivolge
a chi è stato appena strappato alla morte voluta. Ma nessuno se ne uscì
con questa domanda. Il gesto di Natalia era così naturale per tutti, anche
per me che la conoscevo appena. Di quelle mie visite a Natalia
ricordo un corridoio buio dove prima d’entrare in camera c’erano
sussurri e intese tra la vecchia suocera e la cognata. Poi mi fermavo
accanto al letto di Natalia e mi facevo raccontare dei suoi bambini
lontani e della sua famiglia a Torino. Così maturò a un certo punto
la proposta che io le feci di trasferirsi a casa mia a via Cola di Rienzo
finché le sarebbe stato possibile riunirsi con loro.

Mi è rimasto impresso il giorno in cui Natalia fu pronta a lasciare
la pensione di via Balbo. La tenevamo sotto braccio io e Pavese. Non
c’erano ancora mezzi di trasporto pubblici e di quel lungo percorso
a piedi mi è rimasto impresso, come nella visione di un cannocchiale
rovesciato, solo la nostra uscita alla luce dal tunnel del Tritone. Neppure
un terzo di strada per arrivare a casa in via Cola di Rienzo.
Non so più in che stato fosse l’appartamento di via Cola di Rienzo,
al quinto piano in quei mesi senza ascensore. Certo non c’erano
più né cimici, né sfollati, ma non credo neppure che fosse proprio
come racconta Natalia:
Discorriamo così fino a notte alta e beviamo del tè nero e amaro. Abbiamo
un materasso e un letto e ogni sera facciamo a pari o dispari
per chi di noi due deve dormire nel letto. Al mattino quando ci alziamo
le nostre scarpe rotte ci aspettano sul tappeto.
Solo un po’ più tardi a via Cola di Rienzo ci sarà il pieno di ospiti:
quando Renzo Passerini, arrivato a Roma dal campo di concentramento
in Africa, teneva nella sala da pranzo di via Cola di Rienzo un
grande gommone che gli serviva per dormire, e Marcella Rinaldi (del
gruppo Nevers), teneva pigiama, asciugamano e spazzolino da denti
nascosti nella cassa del grande pendolo antico, in «salotto», per avere
un posto dove andare quando i difficili rapporti con i genitori la
spingevano fuori di casa. Ma quando venne Natalia l’appartamento
era ancora vuoto e in corridoio c’erano le nostre biciclette ogni volta
portate a spalla per cinque piani, e proprio la bicicletta fu di grande
aiuto per la ripresa di Natalia.
Un giorno venne a cercarmi, da Einaudi, una persona che diceva
di aver tanto sentito parlare di me. Non so come e dove aveva letto
la mia calligrafia e questo era stato il fatto decisivo. Era Giuliana
Benzoni.
Io non sapevo ancora nulla di lei, non sapevo che aveva avuto una
certa parte nella caduta del fascismo, nulla dell’amicizia con Maria Josè,
che nei mesi precedenti l’arresto di Mussolini aveva incontrato
spesso, proprio grazie a Giuliana, personaggi di vecchie e nuove formazioni
politiche. Giuliana Benzoni era l’amica fidata incaricata di
«portare il cavallo di Troia dell’antifascismo all’interno del Quirinale».
Tanto meno sapevo del passato remoto di Giuliana. Nella Prima
guerra mondiale, come giovane combattente per «le nazionalità»,
aveva partecipato attivamente alla costruzione del libero Stato democratico
in Cecoslovacchia. Era stata fidanzata e compagna di lotta
di Milan Stepanik, l’eroe cecoslovacco il cui aereo fu colpito in
uno degli ultimi giorni della Grande guerra. Con questa morte era
finita la vita privata di Giuliana, che però rimase amica e spesso ospite
di Masarik, che di Milan Stepanik era stato padre adottivo.
Queste notizie le ho apprese solo di recente leggendo le memorie
che Giuliana Benzoni ha dettato a Viva Tedesco. Giuliana parlava pochissimo
di sé, perché non si riteneva di per sé importante, ma solo
strumentale. E anche delle cose che riteneva importanti parlava solo
per flash, come quel personaggio di De Filippo che si esprimeva solo
con i mortaretti. Anzi mi viene da dire che parlava a pezzi e bocconi,
ricordando lo sfilatino che spuntava dal suo borsone pieno di
carte; era lo sfilatino che dal periodo clandestino aveva abitudine di
sbocconcellare per un casuale pasto di mezzogiorno che di solito finiva
in quel modo.
Così a pezzi e bocconi seppi della sua amicizia con don Orione e
degli anni giovanili passati nel Sud lavorando per l’Associazione per
gli interessi del Mezzogiorno. Seppi anche che aveva una casa a Capo
di Sorrento. Era la bella villa dove viveva sua madre donna Titina,
La Rufola, che poi ospiterà Gaetano Salvemini nei suoi ultimi
anni. Sempre a pezzi e bocconi seppi che Adriano Olivetti la evitava
perché credeva di dovere a una qualche sua imprudenza verbale il fatto
stranissimo che per suggerimento del Servizio segreto militare
fosse stato arrestato proprio dal governo Badoglio.
Giuliana Benzoni venne da Einaudi per dirmi che si stava costituendo
un grande movimento che doveva occuparsi della ricostruzione
morale degli italiani e dell’educazione alla democrazia. Lei sapeva
che era molto importante la mia adesione. Io non ero nessuno,
non avevo partecipato alla Resistenza e non ero stata attratta da nessun
partito, ma l’idea di imbarcarmi in questa specie di avventura
mi attraeva. Così lasciai il lavoro da Einaudi e cominciai a occuparmi
a mezzo tempo del Movimento di collaborazione civica. La mattina
insegnavo storia alla scuola di Nevers.
Si costituì un comitato promotore di cui facevano parte personaggi
di vari partiti sotto la presidenza di Leopoldo Piccardi, un illustre
giurista che era stato ministro del lavoro durante il governo Badoglio
e malgrado l’aspetto compassato di alto funzionario, risultò il
più fantasioso di tutti. Ricorda Vittorio Foa:
Come ministro del lavoro del governo Badoglio favorì anche un accordo
tra sindacati e Confindustria per il riconoscimento delle Commissioni
interne, organi di rappresentanza operaia soppressi dal fascismo
appena arrivato al potere: il segnale più importante di libertà
sindacale.
Con Piccardi, insieme a don De Menasce, che era stato amico di
Maritain, sedevano intorno allo stesso tavolo altri illustri intellettuali
che facevano parte attiva del Pci.
Piccardi scrisse una solenne dichiarazione di intenti. Il Movimento
fu regolarmente istituito il 29 novembre 1945.
Giuliana trovò subito una bella sede in un vecchio palazzetto di
via dei Delfini. Più tardi ottenne per l’Mcc da Margherita Caetani di
Bassiano addirittura l’uso del castello di Sermoneta per i nostri corsi
residenziali, e più tardi ancora il piano nobile di palazzo Del Drago.
Piccardi, ma soprattutto Giuliana Benzoni, si davano da fare per
avere nuove adesioni importanti e soprattutto per trovare finanziamenti.
A distanza di anni si capì che Giuliana per amore della collaborazione
civica era arrivata a ipotecare senza speranza le sue proprietà
fino al punto che non si poté salvare neppure la famosa villa
di Sorrento, La Rufola.
In questo comitato di intellettuali io avevo l’incarico di tradurre
in azione concreta gli intenti.
Il momento era quello giusto. La vita nuova cominciava con quel
2 giugno del ’46 quando festeggiammo la nascita, anche se piuttosto
stentata, della Repubblica, e demmo il via, anche con il voto delle
donne che per la prima volta erano ammesse a votare, ai lavori
della Carta costituzionale che ci riscattava (credevamo per sempre)
dal fascismo.
Per la prima e ultima volta quel giorno partecipai a un grande corteo
insieme a tanti giovani. Ero con i primi volontari reclutati dal
Movimento di collaborazione civica: c’erano anche alcune alunne
del liceo di Nevers che sfidavano, con la partecipazione alla festa
della Repubblica, la stretta osservanza monarchica di quasi tutte le loro
famiglie e probabilmente anche quella delle suore di Nevers.
La mia prima mossa era stata quella di organizzare un volontariato
di giovani studenti liceali che si occuparono, nell’estate del 1946,
delle primissime colonie estive. L’Italia era a pezzi, ma era tutta nuova
per altri aspetti: era bastata una lettera ben fatta, indirizzata ai
presidi di alcuni ginnasi-licei di Roma, perché loro si mettessero in
moto per reclutare gli studenti e raccogliere un certo numero di adesioni.
Chiedevamo un mese delle loro vacanze per mettere su le prime
colonie estive per i bambini più disastrati.
Ma un’ottantina di questi
giovani, senza aspettare l’estate, fu subito occupata per dei turni
di lavoro nell’ufficio Prigionieri di guerra della Croce rossa italiana e
altri lavoravano a turno in un campo profughi presso la caserma La
Marmora in Trastevere, per organizzare un doposcuola per i bambini
sfollati. Il gruppo Nevers era in testa alla squadra di volontari. La
qualità delle prestazioni era estremamente curata e così la preparazione
dei giovani studenti volontari. Eravamo critici verso le opere assistenziali
del regime fascista e in particolare verso le colonie estive
che avevano ammassato in grandi edifici, costruiti a questo scopo, migliaia
di bambini in una specie di organizzazione premilitare. Di quel
mondo e di quell’organizzazione sopravvivevano sulla costa adriatica,
e in parte anche tirrenica, gli scheletri dei colossali edifici delle
colonie fasciste distrutti dal passaggio della guerra.
Giuliana conosceva un illustre latinista, direttore dell’Istituto di
Studi romani, che si era largamente compromesso con il fascismo
1946, colonia con i giovani volontari del Movimento di collaborazione civica all’Orto
botanico di Roma anche per le tante lapidi in latino sparse un po’ dovunque a Roma
per celebrare i fasti dell’impero fascista. Per questi meriti il governatorato
di Roma aveva assegnato all’Istituto di Studi romani una sede
prestigiosa sull’Aventino, l’antico convento di Sant’Alessio. Giuliana,
immaginando che il professore avesse una certa voglia di fregiarsi di
altri meriti, ottenne per l’Mcc ospitalità per un seminario di educazione
democratica che si tenne durante le vacanze di Pasqua. Tra i docenti
che spiegavano, tra le altre cose i programmi dei vari partiti,
c’era Guido Calogero, al quale piacque tanto quella sede da destinarla
in seguito alla scuola per assistenti sociali, il Cepas, che doveva iniziare
la sua attività l’anno seguente.
Tra i docenti c’era anche un singolare istruttore che Giuliana aveva
pescato fra le truppe alleate, un assistente sociale, il sergente Hauser,
fanatico apostolo della democrazia e dell’educazione degli adulti.
Conosceva tutti i trucchi che servono ad accattivare l’attenzione,
parlava un italiano pessimo senza scomporsi, sia che si rivolgesse ai
nostri studenti sia a un auditorio composto di colonnelli da rieducare
scelti nel nostro scalcagnatissimo esercito.
La preparazione dei volontari continuò nei frequenti contatti nell’ufficio
di via dei Delfini, e nelle letture ed esercitazioni che organizzavamo:
qualche pagina di Dewey, l’analisi dei libri di testo scolastici
dell’era fascista, il materiale didattico che esperti inglesi e americani
di pedagogia ci procuravano.
Questo primo nucleo di giovani, forse perché si trattava dei «fondatori»,
fu particolarmente curato e si formò saldamente come gruppo
grazie a una settimana che passammo tutti insieme in una ex colonia
estiva di Monteluco sopra Spoleto, con l’aiuto dell’amministrazione
comunale che era presieduta da un vecchio patriarca
socialista, eletto sindaco subito dopo la Liberazione. Con lui imparammo
sul campo a conoscere la vita di un comune in uno Stato democratico.
Credo che quello di Monteluco sia stato in assoluto il primo
corso residenziale laico e, come noi sperimentammo per tanti
anni in seguito nel castello di Sermoneta, la bellezza e la pace dell’ambiente
circostante (pure nell’estrema povertà degli interni) era
la parte più importante di questi corsi residenziali.
Lo stesso gruppo dei «fondatori» ebbe anche il discutibile privilegio
di un durissimo soggiorno sportivo nei monti Sibillini, ospiti di una
casa cantoniera della provincia di Perugia. I miei fratelli e io la conoscevamo
bene da tempi remoti perché andavamo a sciare da quelle parti
sotto la guida di un esperto sciatore di Terni, detto «Marocco», che
per mestiere sorvegliava tra quelle montagne le linee ad alta tensione
della società Terni. Per arrivare a questa casa cantoniera si lasciava a
Norcia il trenino che univa Spoleto a Norcia. In un accidentato percorso
attraverso tanti ponti di pietra e continue gallerie ti facevano scoprire,
come alla luce di un lampo, la segreta bellezza della Valnerina.
L’alberghetto di Norcia sistemò alla meglio i letti per questa quarantina
di giovani e ci servì una cena rustica come «l’umile Italia» di
quegli anni sapeva apparecchiare con amore. La mattina dopo, sacco
e sci in spalla camminammo per diciassette chilometri fino alla
casa cantoniera della provincia di Perugia, posta a guardia del valico
di Forche Canapine. All’arrivo per conforto non c’era che un immenso
camino acceso e i «viveri per la sopravvivenza» che Giuliana
Benzoni aveva ottenuto da qualche comando alleato.
Ogni partecipante era stato fornito di una scatola di sopravvivenza
che conteneva cibo in forma di biscotti. Bastava un boccone e
non avevi più fame per qualche ora. Il cantoniere Ruggero ci procurava
il vino e qualche pagnotta e nei nostri zaini portavamo altri viveri.
Con il lume di acetilene la sera si leggeva insieme qualche pagina
che completava la felicità del riposo e del calore del fuoco nel camino,
così grande che al suo interno offriva da sedere per una decina
di persone. Proprio il disagio e la povertà di questi corsi residenziali
hanno contribuito a renderli memorabili.
La veglia era un momento particolarmente importante della giornata.
In uno dei tanti corsi che tenemmo a Sermoneta una maestra che
partecipava al corso una volta mi confidò timidamente ma con tanta
tenerezza: «Vede, ci dispiace di andare a letto per paura di dimenticare
le cose che abbiamo sentito durante il giorno». A pensarci bene
nei primi tempi le comodità del castello di Sermoneta non erano
molto di più di quelle che ci offriva la casa cantoniera di Forche Canapine.
Di più c’erano le lenzuola che ci avevano regalato gli American
Friends. Certo avevamo dei saloni in rovina dove riunirci e c’era
una donna che cucinava per tutti. Ma intorno alla casa cantoniera c’era
la meravigliosa chiostra dei monti che si aprono sull’altopiano di
Castelluccio. Allora si diceva che gli abitanti di Castelluccio erano co-
sì gelosi del loro isolamento, quando restavano sepolti sotto la neve,
da prendere a fucilate chi si avvicinava per soccorrerli.
Nell’estate del 1946 cominciò in pieno il lavoro per le colonie dei
bambini. Ci furono affidate dalla Croce rossa tre colonie di cui una
diurna per un complesso di novecento bambini. La bellissima colonia
estiva all’orto botanico divenne il nostro quartier generale. Non mi
ricordo da dove venivano e come arrivavano all’orto botanico quel
centinaio di bambini sparuti che frequentarono per tutta l’estate quella
colonia, forse da Tormarancio o da Valmelaina o da una delle varie
borgate di Roma dove il fascismo poco prima della guerra aveva letteralmente
scaricato la gente dei vecchi quartieri storici demoliti per
fare posto alla via dell’impero o alla futura via della Conciliazione.
La visita e la storia di queste borgate furono il nostro miglior sussidio
didattico per spiegare che cosa era stato il fascismo. Allora in
queste borgate la gente marciva in catapecchie senza acqua né fogne
e teneva il gatto legato ai piedi del letto per proteggersi dalle pantegane.
Il gatto l’avevamo notato alla borgata Gordiani che era proprio
come la descrive negli anni 1951-52 l’Inchiesta sulla miseria e
sui mezzi per combatterla promossa dal Parlamento e rimasta più o
meno sconosciuta.
Baracche basse uniformemente allineate creano un’atmosfera pesante
e grigia. Non si vede un albero né un ciuffo di verde. Ogni tanto nelle
vie laterali si innalzano casotti in cemento a base quadrata di pochi metri
di lato: sono i 25 gabinetti a disposizione di una popolazione di oltre
5.000 persone.
È probabile che ci fossero tra i bambini anche i senza casa dei quartieri
bombardati di San Lorenzo. Di quella colonia estiva all’orto botanico,
esemplare nella sua povertà, ricordo soltanto le tavole bene apparecchiate
lungo tutto il parapetto del Gianicolo con il più bel panorama
di Roma, le tavole che i ragazzi dell’Mcc servivano con tanta
cura e con grandissimo amore. Il cibo proveniva da varie fonti che
Giuliana scopriva probabilmente nelle sue tasche, finché non ottenemmo
cibo dai militari alleati e dal Ministero dell’Assistenza postbellica,
per integrare quel poco che la Croce rossa ci passava.
Un giorno Giuliana portò in visita all’orto botanico un importante
direttore generale di quel ministero appena nato. Era Augusto
Frassineti. Lo ricordo benissimo. Eravamo tutti raccolti ai piedi della
grande scalinata che scende dal Gianicolo al piazzale centrale dell’orto
botanico. Frassineti aveva un’aria severa ed era pienamente
investito del nuovissimo ruolo che aveva assunto. Ma dal suo modo
di trattenersi con tutti noi, di interessarsi all’aspetto pedagogico di
quella nostra impresa, dal modo di promettere aiuti (che sarebbero
arrivati il giorno dopo) ci parve la prima apparizione di quella nuova
classe dirigente che la democrazia avrebbe prodotto. Era una delle
tante aspettative di allora.
Tratto da “Cinquant’anni nell’utopia e il resto nell’aldilà” di Angela Zucconi, Castelvecchi 2015
© Lit Edizioni Srl. Per gentile concessione dell’Editore