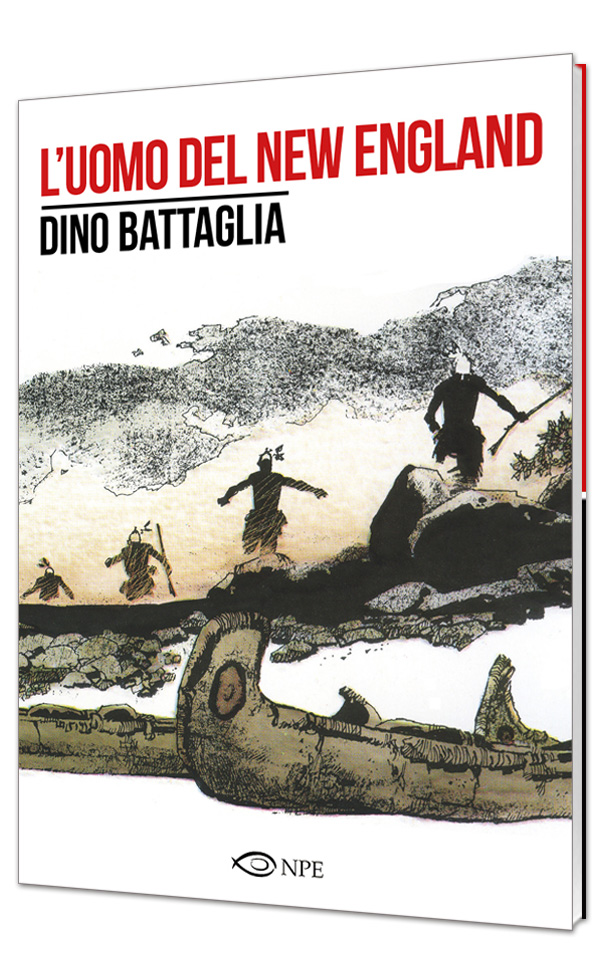L’ultima risata nel giorno della memoria
Oggi è “Il Giorno della Memoria”. Lo celebriamo anticipando una introduzione al e parte del testo teatrale che sarà recitato questa sera alle 21 in diretta dalla Sala A di Via Asiago in Roma (ascoltabile in diretta su Radio3). “L’ultima risata. Comici nei campi nazisti” di Antonella Ottai è l’incredibile storia dei comici nei lager. Le canzoni, gli sketch, l’ironia antinazista degli umoristi della Repubblica di Weimar e la loro deportazione nei campi di concentramento dove erano costretti a far ridere i loro aguzzini.
L’ultima risata
Comici ebrei nei lager nazisti
di Antonella Ottai
L’ultima risata nasce da una ricerca – i cui esiti complessivi sono pubblicati in un volume, “Ridere rende liberi”, in uscita presso Quodlibet – sulle sorti di alcuni comici ai quali si deve negli anni trenta la grandezza leggendaria del cabaret e dello spettacolo leggero mitteleuropeo, in particolare di quello berlinese.
In gran parte ebrei, come ebreo era il colore del loro umorismo, la sorte di questi artisti è segnata dall’avvento di Hitler al potere. Espulsi dai set e dai palcoscenici sui quali avevano primeggiato, le loro performance si replicano in condizioni sempre più dure. Per loro cominciò un viaggio forzoso attraverso l’Europa, progressivamente invasa dall’esercito tedesco. Molti di loro finirono nei lager di transito, prima di approdare in situazioni terminali. Ma la loro arte comica li accompagna fino alle soglie della morte: fecero cabaret nei campi per gli internati, ma anche per i loro carnefici. Ridere per vivere e per sopravvivere; ridere per offendere e per difendersi: la relazione comica, diventa in situazioni estreme, la forma della relazione vittima/carnefice.
Il testo li accompagna nelle diverse fasi della loro tragedia, a partire dalla ghettizzazione: nell’autunno del ’33 nasce a Berlino la Lega della cultura ebraica dove, finché la Gestapo non ne serra i battenti, «l’arte verrà prodotta dagli ebrei solo per gli ebrei». Li segue quindi nella deportazione: prima nel campo di transito di Westerbork, in Olanda, poi nell’“insediamento ebraico“ di Theresienstadt, in prossimità di Praga. Entrambi i lager ospitano fra le varie forme di attività artistica, celebri cabaret, animati dagli artisti tedeschi, olandesi o cechi che vi erano internati. Fino allo sterminio, nel quale la maggior parte degli artisti finirà col concludere la propria esistenza. Le vicende di questi personaggi non raccontano soltanto la storia di alcuni comici – comici di grande successo: la notorietà li accompagnerà fino alla fine – ma inducono, al di là delle specifiche occorrenze storiche, una riflessione sul comico nelle situazioni più estreme.
Il racconto scivola fra la narrazione in prima persona – la Berlino d’epoca rivissuta attraverso le memorie familiari; l’evocazione del repertorio storico – canzoni, ballate, sketch degli anni trenta; le testimonianze di carattere documentale e le riflessioni sul senso e sui paradossi della vicenda narrata.
La lettura/spettacolo L’ultima risata è tratto dal volume “Ridere rende liberi. Comici nei campi nazisti”, di Antonella Ottai, pp. 234. Quodlibet (in libreria dal 28 gennaio 2016). Ne estraiamo una piccola parte-sintesi.
1) È tutta colpa degli ebrei, Felix Hollaender, sulle note della Habanera dalla Carmen di Bizet, traduzione e libero adattamento di Franca D’Amato
Se diluvia o non piove mai,
se c’è una afa che ti fa svenir,
se c’è vento o fa freddo assai
congelato pensi di morir.
S’è bel tempo o coperto è,
se la neve fitta cade giù,
se non basta manco un vin brulè,
o se invece c’è un bel cielo blu.
TUTTI
E’ degli ebrei, è degli ebrei,
la colpa è tutta quanta degli ebrei,
la colpa è tutta degli ebrei,
è sempre e solo colpa degli ebrei.
In culo a chi? Ci vada lei!
Non lo capisce è colpa degli ebrei,
Ci creda o no, non mentirei,
si sa che è solo colpa degli ebrei.
2) «Alla fine, siamo tutti figli di Adamo!… Almeno…. a partire dalla 2° fila».
come disse il cabarettista Max Ehrlich, nel corso di uno spettacolo di rivista nel campo di transito di Westerbork, Olanda, dove era internato, rivolgendosi a un pubblico composto da internati e SS…..
3) «Amici, benvenuti! Siete fortunati a essere qui questo pomeriggio. Qui abbiamo l’arte e gli artisti migliori dell’intera Germania. Qui potete ridere apertamente dei nostri scherzi. Qui c’è il teatro più libero del Reich. Fuori di qui, attori e pubblico sono terrorizzati perché hanno paura di finire in un campo di concentramento. È una cosa di cui noi non ci dobbiamo assolutamente preoccupare… » (presumibilmente, Werner Finck, durante uno spettacolo nel campo di concentramento di Buchenwald)
4) «I trasporti per Auschwitz naturalmente ci stavano – e ci stavano ogni martedì – ma intanto bisognava anche ridere!» La brutale paradossalità di quest’affermazione di Jetty Cantor, fra le poche sopravvissute della compagnia teatrale del campo, la Gruppe Bühne di Westerbork, punta il dito sulla liceità della risata in un contesto di dolore nel quale avrebbe dovuto essere interdetta; e soprattutto sulla sua normalità laddove vigeva lo stato di eccezione….
1.1. Es gibt nur ein Berlin. “Di Berlino ce n’è una soltanto”
Alle soglie degli anni trenta del secolo trascorso, Berlino è il laboratorio europeo della modernità. Un numero infinito di opere ha raccontato la mitologia di una grande capitale di respiro internazionale, tutta proiettata verso il futuro, che precipita invece dentro il nazismo. Molti fra i protagonisti di quegli anni ne hanno scritto le memorie ma il mito, per me, come ogni mythos che si rispetti, si fondava innanzitutto sulla tradizione orale. Prima di essere storia, politica, letteratura, arte, architettura, cinema, teatro o musica non meno che scienza e tecnologia, la città era un racconto – il racconto – di mio padre, che si trovava a studiare presso l’università della capitale tedesca verso la fine degli anni Venti; e non si stancava di affabularlo.
Dopo molto tempo trascorso nei giorni romani, le immagini di Berlino gli si affacciavano all’improvviso, talmente contemporanee da riuscire ancora a stupirlo con la loro carica eversiva, rifiutandosi all’anestesia del ricordo. E ogni conquista degli anni sessanta, nella tecnologia come nelle strutture pubbliche, sortiva immancabilmente in lui la constatazione che «a Berlino c’era già stata»: «Ecco l’ora di Berlino», annunciava la luce che gli accendeva la faccia. E il racconto cominciava.
Berlino usciva dalle sue parole con la forza dirompente del futuro, con la spregiudicatezza della sperimentazione totale del nuovo: urbanistica, cultura, politica, costumi sessuali, identità di genere, estetica, relazioni sociali.
Il luogo in cui tutte queste novità si facevano tempo quotidiano e diventavano discorso comune – sempre stando ai suoi ricordi – era il cabaret.. Cabaret in assoluto, senza aggettivi che ne specificassero la qualità nell’ambito della letteratura, della politica o del semplice intrattenimento, collegandone l’esperienza a un genere piuttosto che un altro, a un locale piuttosto che a un altro, a una tendenza piuttosto che un’altra.
Un luogo pieno di eroi del sorriso, che rovesciavano gli umori della giornata, sobillandone il senso; eroi che viaggiavano ai piani alti e ai piani bassi della cultura urbana e riuscendo a cortocircuitare nelle loro esibizioni superficie e profondità. Più tardi avrei capito che in realtà, nei suoi racconti il “cabaret” non consisteva tanto in una performance teatrale, equivaleva invece a una disposizione d’animo, al desiderio di chiudere il giorno dentro a un gioco che fasciava le notti in un lungo abbraccio ammiccante, quasi che quelle piccole scene, quell’arte della sfumatura, flessibile alle più svariate modalità d’uso e di abuso, potessero mettere in forma al meglio la frenesia del tempo contemporaneo, moltiplicandone e sfaccettandone le manifestazioni all’interno del tessuto urbano.
Era il modo in cui Berlino gli si era mostrata, il paradigma concluso della modernità metropolitana, una tramatura sempre in divenire, che trasformava la città minuto per minuto. Gli arredi si ispiravano di settimana in settimana a un tema visivo, il quale a sua volta innescava e raccordava danze, sketch e spettacoli di arte varia, in una metamorfosi incessante del fronte stradale, nel camouflage moltiplicato di una mascherata a cui ciascuno era chiamato a partecipare. Anche queste espressioni stavano comunque a indicare una pulsione sfrenata e condivisa di spettacolo, che affiorava fra le mille forme di scena urbana – pubblica e privata – e finiva con il produrre evidentemente un teatro più invasivo e una memoria più persistente di quello che, confinato nei palcoscenici, era in grado di soddisfare domande mirate, ma anche più assuefatte.
Il cabaret offriva invece una dimensione più complessa, una relazione fra scena e platea affetta da complici reciprocità con la cultura e la pratica dell’esistenza quotidiana e del suo regime desiderante. Spettacolarità e metamorficità non si limitavano infatti ad agire le scenografie dei locali ma investivano le zone più intime e segrete degli statuti identitari e di genere di coloro che li frequentavano. Agli occhi stupefatti degli ospiti stranieri – e Berlino in quegli anni era un’esperienza cognitiva quasi obbligata per l’intellighenzia internazionale – i notturni urbani si presentavano all’insegna del travestitismo e la capitale tedesca si configurava come la città delle identità instabili, delle esistenze doppie che si alternano fra il tempo dei giorni e quello delle notti, fra l’etica del contegno, di guglielmina memoria e le estetiche del gioco e del desiderio. Nel travestitismo dispensato nei cabaret o nelle sale dei caffè, ciascuno sembrava vivere volentieri un proprio piccolo teatro personale procurando panni e narrazioni proprie al maschile o al femminile che magari, durante la normalità delle ore lavorative, dormivano quiete nella sua persona. […]
I cambiamenti non si sarebbero limitati a questo. L’ultima catastrofica metamorfosi – la trasformazione della capitale della repubblica di Weimar in capitale del III Reich – impartiva al racconto di mio padre un andamento epico. Le vetrine infrante e le saracinesche scardinate di negozi che appartenevano a proprietari ebraici, mostravano senza ombra di dubbio quale sarebbe stato il capro espiatorio di una politica che, da destra e sinistra, si accusava di ogni infamia:
Se diluvia o non piove mai,/ se c’è un’afa che ti fa svenir,/ se fa scuro, se tuona,/ se c’è il vento o fa freddo assai,/ congelato pensi di morir./ S’è bel tempo o coperto è,/se la neve fitta viene giù,/ se non basta mano un vin brulè,/ o se invece c’è un bel cielo blu./ È degli ebrei, è degli ebrei,/ la colpa è tutta degli ebrei./ In culo a chi? Ci vada lei./ Non lo capisce è colpa degli ebrei./ Ci creda o no, non mentirei./ Si sa che la colpa è solo degli ebrei.!
An allem sind die Juden schuld, “di tutto sono colpevoli gli ebrei”, aveva orchestrato nel ’31, sul motivo della Habanera della Carmen di Bizet, Felix Hollaender, uno dei più celebrati autori di riviste e cabaret (collaboratore di Reinhardt e compositore per Mehring e Tucholsky, fra gli autori più importanti del cabaret politico-letterario. ..
Insieme a una piena di persone in fuga, anche mio padre aveva abbandonato Berlino, ma non se ne era tornato a Budapest e nemmeno a Vienna, città dove era di casa.. Era invece arrivato a Roma. Al punto esatto dell’approdo a Roma, si spegneva «L’ora di Berlino»: i suoi personaggi svanivano nel traffico delle fughe, e nei traffici della nostra giornata quotidiana che la narrazione aveva messo in pausa. Io tornavo ai miei libri e alle loro profondità senza superficie, e cercavo nomi e storie finite insieme ai racconti di mio padre, che per me restava l’unica fonte che li teneva in vita. Finché non ne ho ritrovato il seguito, ma il racconto aveva cambiato del tutto genere di riferimento…
Antonella Ottai ha insegnato presso il Dipartimento di Storia dell’arte e Spettacolo dell’Università “Sapienza” di Roma. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni sullo spettacolo italiano e internazionale degli anni Trenta, con particolare attenzione alle scene comiche (“Coma a concerto. Il Teatro Umoristico nelle scene degli anni Trenta”, “Eastern. La commedia ungherese nello spettacolo fra le due guerre”). Presso Sellerio, ha pubblicato un libro di racconti autobiografici, “Il croccante e i pinoli”.