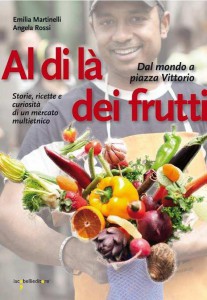Erri De Luca e la fame a Roma
Ringraziamo l’editore Iacobelli per l’anticipazione offertaci da questo bel racconto di Erri De Luca. E per l’uso delle foto che lo illustrano. Entrambi tratti da “Al di là dei frutti. Dal mondo a piazza Vittorio. Storie, ricette e curiosità di un mercato multietnico” di Emilia Martinelli e Angela Rossi.
La città e la fame
di Erri De Luca
La fame fa vergogna e chi la patisce fa finta di no. Mi è capitato e me
la sono tenuta. E poi ero giovane, fa meno danno al corpo e meno
male al resto. Quando l’ho rivista negli altri, l’ho riconosciuta. Bisogna
avere l’occhio esercitato. La fame non è quella che si vede nei filmati,
i corpi scheletriti, i bambini con la pancia gonfia d’aria. Quella è persecuzione,
umanità schiacciata.
La fame è una bestia che isola in mezzo agli altri sazi. Si capisce
dagli occhi l’affamato, sono quelli dei cani rinchiusi nel canile. Guardano
agli altri le mani, sono lingue che cercano la briciola rimasta.
Il resto del corpo nasconde la fame, gli occhi non ce la fanno.
La sera viene umiliazione ma pure orgoglio: si passa davanti a
un’osteria senza voltarsi per guardare dentro. Oltrepassare tavole
imbandite con lo stomaco vuoto da qualche giorno, tirare dritto senza
neanche tapparsi il naso è un atto di amor proprio che sprigiona un
po’ di caloria, buona in inverno. Avevo fame a Roma, città raggiunta
da poco, indifferente ai randagi, tranne ai gatti. Non sapevo chiedere
e non ho imparato.
Un giorno di quel primo inverno da spaesato entrai in una manifestazione
dalle parti dell’università, piazzale delle Scienze. Ora ha
cambiato nome, porta quello dell’unico politico italiano morto
ammazzato, rarissimo destino.
Entrai nella manifestazione, c’erano studenti fuorisede, operai di
una fabbrica di pasta, ferrovieri. A quel tempo le categorie e le ragioni
si mettevano insieme. Ci fu uno scontro con i reparti della pubblica
sicurezza. A differenza del loro titolo, quei reparti si prestavano più
volentieri alla sicurezza di qualche interesse privato, invece che pubblico.
Lo scontro mi sospese la fame e finì in pareggio. La manifestazione
non riuscì nell’intento di raggiungere il centro, ma neanche fu dispersa.
Rimase intorno all’università. A mezzogiorno stava ancora là.
Gli studenti fuori sede proposero di andare tutti alla mensa universitaria.
Quel giorno si mangiò gratis grazie all’accoglienza e alla
solidarietà degli addetti a quel servizio. Quel giorno mangiai quello
che non mi capitava di mettere insieme in una settimana. Poi successe
il contagio: quella mensa aperta a tutti in un giorno di lotta, restò
aperta. In un’assemblea i lavoratori imposero di non discriminare tra
chi era studente e chi no. All’ingresso non si doveva controllare più
il tesserino. Così finì il mio tirocinio di affamato, da un giorno all’altro.
Succede da sera a mattina quello che non succede in dieci anni. Il
tempo allora si spostava a scatti. Quel giorno passando vicino alla donna
con gli occhi truccati non la desiderai.
Mi giravo in tasca i soldi che servivano a pagare il letto nella
camera vicina alla Stazione Termini, dove si dormiva in tre.
Il padrone di casa li voleva anticipati e faceva bene, perché veniva
tentazione di intaccarli per dare uno sfogo al sesso, che in certe ore
della gioventù coincide con se stesso. Guardavo le donne che vendevano
la loro compagnia. Mi ero fissato con una, la guardavo, lei pure,
ma sapeva a vista che ero vuoto in tasca.
Così è successo che nel primo autunno/inverno a Roma la fame
aveva gli occhi truccati di quella donna. Forse era una ragazza, ma a
me sembrava donna da marito. La fame ingrandisce. Quella dello stomaco
si alleò con quella di più giù, e tutt’e due erano lei che saliva
in camera con chi metteva mano al portafoglio. Forse anche lei chiedeva
anticipato. Le donne hanno l’istinto di andare con i sazi.
Non l’ho avvicinata, non sapevo chiedere.
Non provo gratitudine per quella mensa universitaria, adesso e
neanche allora. Erano tempi politici dal basso, facevano cambiare le
cose materiali mettendo insieme persone sconosciute ma concordi,
e puntuali meglio di un appuntamento. Un ragazzo schizzato fuori
dal suo posto di origine poteva essere nutrito da una folla compatta.
Capivo che la politica era una strada camminata al centro. Entrare in
quella politica era scendere un gradino di marciapiede e unirsi a una
corrente. Condividere una lotta sospende le cerimonie grazieprego,
in entrata e in uscita.
Quel ragazzo vedeva il mondo muoversi e cambiare i rapporti di
forza tra potenti e deboli, dal Vietnam a via De Lollis, da una lotta di
liberazione fino all’ingresso di una mensa in cui poteva entrare senza
tessera. Vedere il mondo rigirarsi, scrollarsi schiavitù e sottomissioni,
fa bene alla salute di una gioventù. Anche sfamarsi era stato un atto
politico. Anche l’amore: nella corrente che gridava a ritmo di sillabe
in rivolta, ci si prendeva per mano. Le ragazze non si truccavano gli
occhi. Non era pratico il rimmel con i lacrimogeni.
Per la sete invece l’urgenza è tutt’altra, la privazione è intrattabile.
L’acqua è fabbisogno affine all’aria. Ho provato riconoscenza definitiva
per chi mi ha dissetato. È successo in montagna, durante una scalata
lunga un giorno.
Affrontavo una parete a nord, cordata a due. Le pareti a nord sono
in ombra nel nostro emisfero, sono più fredde.
Avevo con me una borraccia d’acqua. Metà se n’è versata nello
zaino, colpa mia, metà l’ho bevuta durante le prime ore di scalata.
Quella parete era a nordest, dunque esposta al sole nelle prime ore
del mattino, quelle nostre. Il termine della scalata non coincideva con
la cima, per raggiungerla ci voleva un’altra ora. Finita la borraccia soffrivo
la sete. La parete era completamente asciutta, mettevo le labbra
sulla roccia dove trasudava il residuo umido. Non bastava. Avevo giustamente
rinunciato a orinare, lo stimolo era finito, il corpo si era
ripreso il liquido della vescica.
Durante le altre lunghe ore di discesa la sete mi ossessionava. Mi
infuriavo per ogni goccia di sudore che continuava a scorrere. Arrivato
a un punto di confusione mi sono fermato. Il compagno di cordata,
di specie cammelliera, era abituato a non bere e a non sudare. Lo credevo
capace di assorbire acqua dall’aria. Del resto i pesci assorbono
ossigeno dall’acqua. «Ma i pesci bevono?»: quando vengono in mente
simili domande in un giorno di sforzi a esaurimento, significa che la
testa se ne sta andando. Quando le pronunci all’improvviso seduto in
mezzo a una parete sterminata, la testa se n’è andata ufficialmente per
i fatti suoi.
Il compagno ha capito. Dallo zaino cava una borraccia quasi vuota,
me la offre. Mi sono vergognato di accettarla ma l’ho presa. La sete,
diversa dalla fame, non consente amor proprio. Ho succhiato quell’acqua
rigirandola dentro la bocca, sotto le gengive. A piccoli ingoi
ho svuotato il fondo. Si è snebbiata la testa. Ho pronunciato un grazie
lento, sillabato, da straniero.
Si dicono molti grazie di buona educazione, pochi di gratitudine
pura. Quando succede il grazie di un soccorso, uno si accorge di pronunciarlo
devotamente, con buffa solennità.
«Se avete fame, guardate lontano», cantavo con mio padre «Monte
Canino», canzone alpina della prima guerra. C’era rimedio alla fame,
si poteva governarla guardando lontano.
Come il mal di mare, la fame si ammansiva col respiro profondo
di chi mette a fuoco l’orizzonte.
Il verso seguente cantava: «Se avete sete, la tazza alla mano, che
vi disseta la neve ci sarà». Contro la sete non c’erano espedienti. Bisognava
bere e andava bene pure una gavetta di neve da sciogliere in
bocca. La fame è stata un brontolio di viscere e il desiderio di abbracciare
la vistosa in offerta alla Stazione. Mi riusciva di darmi le pazienze
utili a non chiedere. La sete no, perciò per me somiglia a quella folla
in piazza, che aveva smesso di tenersi le mancanze, di starsene docile
al comando.